La Conversazione tra un razzista e un non so (qui) che Grillo ha pubblicato e diffuso il 19 giugno, è un concentrato di luoghi comuni e pregiudizi che intenderebbe mostrare la razionalità del discorso razzista e l’irrazionalità di chi, invece, al razzismo in tutte le sue forme si oppone (figura a cui Grillo attribuisce l’epiteto di “non so”, a riprova della sua convinzione che chi si oppone al razzismo non abbia le idee chiare, sia confuso e indeciso, addirittura ignavo e incapace di prendere posizione, nonché poco razionale). Tale conversazione fornisce una serie di argomentazioni tipicamente attribuite all’una o all’altra parte, con l’obiettivo di sostenere, con autoironia da parte di Grillo, la parte del razzista. Lo scopo dell’analisi di tali argomentazioni, condotta qui di seguito, è mostrare che non si tratta affatto di autoironia.
Razzista: Io sono un razzista
Non so: Io invece non so, anzi no.
Come già accennato, è chiara la netta distinzione tra il primo personaggio, sicuro delle proprie posizioni (quelle che i “buonisti” certamente pagati dal PD, corrotti e collusi con il sistema, definirebbero “razziste”) e il secondo, che fin da subito appare come la parte debole della conversazione, incapace di addurre argomentazioni forti e convincenti, suggerendo di non essere lui stesso debole e poco convinto delle ragioni che fornisce.
Razzista: Chi entra nel mio Paese deve essere identificato
Perché? Il motivo non viene enunciato né suggerito. Anzi, né ora né nel seguito della conversazione verrà mai spiegato per quale motivo chiunque entri in un paese debba essere sottoposto a identificazione. Si sappia che la motivazione legalitaria autoassolutoria “perché così vuole la legge” non è sufficiente, perché dimentica che la legge è un prodotto sociale e non un principio assoluto, e si sappia che in certi paesi tali richieste sono considerate vessazioni se non violazioni dei diritti civili. In ogni caso, il motivo non è spiegato, perché il “non so”, invece di chiedere delucidazioni in merito, decide ingenuamente (perché così è appositamente costruito il personaggio) di cambiare discorso e di etichettare l’interlocutore subito come razzista.
Non so: Perché sei un razzista. Io accoglierei tutti. Sono tutti esseri umani
Razzista: E chi paga 1050 euro al mese cadauno? Mia madre prende la metà, la pensione minima, dopo aver lavorato e pagato tasse dirette e indirette per 30 anni.
Non so: Ne fai una questione di soldi, ma quanto abbiamo rubato noi a questi popoli? Li abbiamo depredati delle loro risorse come potenze coloniali e ancora oggi. Non si possono mischiare diritti umani e denaro. A chi ti chiede aiuto devi tendere la mano.
Pur senza opportune verifiche e ulteriori analisi che comunque altrove andrebbero condotte, accettiamo per buona la cifra riportata. Il motivo per cui si spende denaro per ciascun migrante è intrinsecamente legata a come è gestito il fenomeno dell’immigrazione: i centri di identificazione ed espulsione, gli apparati repressivi, lo smistamento e il trasporto coatto di migranti da un centro all’altro, la gestione militare dei fenomeni migratori, il sistema carcerario e l’amministrazione di una giustizia discriminatoria costano. Se queste cose non esistessero, non esisterebbero i costi aggiuntivi di cui la collettività si sobbarca per l’accoglienza di ciascun migrante (aggiuntivi rispetto a quelli che sono naturalmente dovuti, per costituzione e per banale applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani, nei confronti di qualunque persona). Ma il “non so” non spiega che se l’immigrazione costa è proprio perché è gestita di proposito come un affare da cui trarre il massimo del profitto economico (che non si ferma a questi meccanismi, ma continua nelle condizioni di sfruttamento estremo in cui i migranti, essendo ricattabili, sono costretti a lavorare una volta arrivati). Invece, il “non so” prende per buono il fatto che l’immigrazione sia un costo, e parla, non a torto, delle responsabilità coloniali che “noi” (vedi qui sull’uso del noi in questi casi) abbiamo nei confronti dei popoli depredati. Questo discorso è sviluppato in una catena di frasi fatte (“non si possono mischiare diritti umani e denaro”; “a chi ti chiede aiuto devi tendere la mano”) che si risolve in un ingenuo richiamarsi a principi di carità cristiana (quella carità cristiana in nome dei quali quegli stessi popoli sono stati soggiogati, ma lasciamo perdere: dopo tutto lui è un “non so”, non ci si devono certo aspettare analisi acute e puntuali).
Razzista: L’Africa ha 1,1 miliardi di persone, in Italia non ci starebbero neppure se messe in piedi una contro l’altra. L’Italia è già oggi una delle Nazioni con la più alta densità di popolazione del mondo. Chi dovrebbe decidere chi può rimanere visto che non possiamo accogliere tutti?
L’Africa (ma perché proprio l’Africa?) ha 1,1 miliardi di persone. Ovviamente non potrebbero mai stare tutte in Italia. Ma chi ha mai detto che 1,1 miliardi di persone dovrebbero stare tutte in Italia? Quest’affermazione, neanche pienamente sottintesa: 1) agita lo spauracchio di un’invasione che non c’è (qui qualche dato), uno spauracchio che può far paura solo ad un elettorato xenofobo, consapevolmente o meno; 2) ingigantisce le proporzioni dei flussi migratori, che interessano esigue percentuali delle popolazioni di origine dei migranti: immaginare che tutti gli africani si stiano attualmente muovendo verso l’Italia o che siano intenzionati a farlo è pura falsità; 3) insinua che essere a favore dell’accoglienza significhi essere a favore dello spostamento di 1,1 miliardi di africani in Italia, cioè di una cosa che non succederà mai, a prescindere dalle scelte politiche nella gestione dei flussi migratori, per il semplice motivo che non è così che funzionano i flussi migratori.
Non so: Basta identificare i profughi che hanno diritto di asilo dai clandestini che sono molti di più.
Questa frase del “non so” è un capolavoro, sia per la natura del personaggio che la pronuncia sia per i contenuti. Infatti, non soltanto il “non so”, cioè colui che dovrebbe almeno provare a opporsi razionalmente e lucidamente alle argomentazioni dell’altro, accetta senza battere ciglio l’improbabile teoria dell’interlocutore secondo cui in assenza di controllo dei flussi 1,1 miliardi di africani si riverserebbero in Italia (non in Europa, proprio in Italia), ma anche spiega che c’è un modo per evitare questo: identificare i profughi, consentendo loro l’ingresso in Italia in virtù del rispetto del diritto d’asilo, distinguendoli dai clandestini, che resterebbero fuori. Poco importa il fatto che, per definizione, profugo è «colui che è costretto ad abbandonare la sua terra, il suo paese, la sua patria in seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali, oppure a cataclismi» (cito il dizionario) e clandestino è chi, «straniero, per varie ragioni non sono in regola, in tutto o in parte, con le norme nazionali sui permessi di soggiorno» e che dunque una netta distinzione tra le due condizioni può non essere possibile, perché niente esclude che le due figure si sovrappongano nella stessa persona.
Razzista: In Italia per il riconoscimento ci vuole più di un anno contro il limite di un mese posto come regola a livello internazionale, nel frattempo il clandestino rimane in assoluta libertà senza identità. Si preoccupano dell’Isis quando potremmo avere decine di affiliati all’Isis al giorno in più dovuti agli sbarchi di cui nessuno sa nulla. Nessuno controlla.
Ammiccamenti continui alla retorica e ai contenuti razzisti qui sono evidenti. Secondo il razzista, “il clandestino rimane in assoluta libertà senza identità”, ma davvero si può parlare di libertà, per di più assoluta, in una condizione di estrema ricattabilità, visto che mancano i documenti e dunque si rischia in ogni momento l’espulsione? Il razzista poi passa alle insinuazioni, formulate su basi nulle ma anche qui avallando teorie del tutto campate per aria, che tra i migranti che sbarcano disperati dopo una traversata in cui rischiano la vita si annidino pericolosi membri del terrorismo internazionale targato ISIS. Perché si sa, i terroristi sono degli sprovveduti che per arrivare in Europa son costretti a salire clandestinamente sui barconi. Poco importa il fatto che gli attentati terroristici verificatisi in Europa sono sempre (non saprei trovare neanche un’eccezione) stati organizzati e messi in atto non da stranieri, ma da persone di nazionalità europee. Agitare ancora questo spauracchio significa associare arbitrariamente l’immagine del migrante a quella del terrorista. Il passaggio tra questa frase e la precedente indica una cosa: che per il razzista è del tutto inutile la distinzione tra profugo e clandestino, perché anche volendo accogliere solo i profughi, ci saranno sempre clandestini tra i piedi, visto che l’identificazione richiede più di un anno.
Non so: E allora cosa dovremmo fare? Lasciarli morire in mare? Sei disumano.
Razzista: Bisogna avere una vera organizzazione di accoglienza, non lasciarli prostituire, in particolare i minorenni come succede alla stazione Termini, o consegnarli alle mafie che li usano come schiavi o lasciarli senza strutture igieniche a bivaccare nei parchi e nelle stazioni. O appollaiati sugli scogli come quelli davanti a noi?
Degno di nota è qui il fatto che il razzista non risponde alla domanda del “non so”: dovremmo lasciarli morire in mare? Ma poi chi, tutti i migranti o solo i clandestini? Non è chiaro. In ogni caso, il razzista che intende identificare ed espellere i clandestini accettando, forse, i profughi, parla della necessità di costruire una vera organizzazione di accoglienza (non si capisce bene a chi dovrebbe essere destinata) per evitare che questi stranieri fastidiosi bivacchino nei parchi, giacché arrecano danno al decoro urbano e a volte si spingono a livelli di disturbo tali da permettersi (addirittura!) di appollaiarsi sugli scogli perché schiacciati da forze dell’ordine italiane da un lato e francesi dall’altra, dal momento che ogni Stato li respinge.
Non so: Per accogliere in modo degno queste persone dobbiamo avere strutture che funzionano e dare loro la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. E’ elementare.
Razzista: Le strutture sono nelle mani delle mafie e dei partiti come è avvenuto a Roma con Mafia Capitale e per inserirli nel mondo del lavoro ci vogliono due requisiti: una professionalità e la conoscenza della lingua italiane. A me sembra che di solito chi entra in Italia non possieda nessuno di questi due requisiti. E soprattutto in Italia il lavoro non c’è, le giovani generazioni di italiani dopo il diploma o la laurea emigrano all’estero.
Finalmente il razzista si è accorto, cosa che invece aveva mancato di fare all’inizio della conversazione, che se si pagano “1050 euro al mese” per ogni migrante la causa è da ricercarsi nelle strutture mafiose che gestiscono il fenomeno dell’immigrazione. Non contento di aver svelato l’origine dei costi dell’immigrazione, si lancia a capofitto in una serie di considerazioni sull’inserimento dei migranti nel mondo del lavoro, affermando che i migranti che entrano in Italia di solito non posseggono una professionalità. Ovvero? Ma poi, stiamo parlando dei migranti in generale, dei cosiddetti clandestini o dei profughi? Perché, per esempio, se stiamo parlando dei profughi, davvero si vuole subordinare l’accoglienza ad una non meglio precisata “professionalità”? O, ancora più insensatamente, alla conoscenza della lingua italiana? “Mi dispiace, lei è un profugo siriano, ha rischiato la vita per venire fin qui, sta scappando da una guerra civile con centinaia di migliaia di vittime e che ha smembrato città e famiglie, ma non parla l’italiano e quindi prego da questa parte, la riaccompagno alla frontiera e non faccia troppe storie”. Per non parlare dell’ormai ridicola idea che la presenza dei migranti diminuisca le opportunità di lavoro per gli italiani (perché sì, in un mondo razzista esistono lavori “per gli italiani”).
Non so: Oltre a razzista sei anche nazionalista. Perché uno dovrebbe essere costretto a parlare la nostra lingua? Forse tu parli lo swahili?
Razzista: E’ un discorso di integrazione. Se non comunicano non possono relazionarsi. Si creano delle isole sociali, dei ghetti. Per chi entra in Italia senza conoscere l’italiano e vuole ottenere la residenza deve essere obbligatorio l’insegnamento della nostra lingua con un esame finale.
Le isole sociali, i ghetti e l’emarginazione non hanno nulla a che vedere con la padronanza della lingua italiana, ma a questo punto spiegare questo sarebbe un buco nell’acqua. Il razzista invoca la necessità di un esame di lingua italiana per chi vuole ottenere la residenza. Ma cosa c’entra la residenza non è dato sapere, dato che una minuscola parte dei migranti che giungono in Italia sono intenzionati a restarci.
Razzista: Vorrei aggiungere che prima di entrare in Italia, e non dopo, per ognuna di queste persone dovrebbe essere prevista una visita medica accurata per verificare se sono portatori di malattie e, in questo caso, curarli, sia per loro che per evitare che malattie scomparse da decenni ricompaiano, come la scabbia, la malaria o la tbc.
Ormai il razzista ci ha preso gusto e non gli basta più lo spauracchio del terrorismo internazionale e dell’invasione di africani: soffiando sul fuoco della propaganda razzista, comincia con la paranoia delle malattie che verrebbero portate nella civile e cristiana Europa da rozzi barbari infetti. I cui rispettivi paesi d’origine, magari, non sono ancora riusciti a debellare certe malattie perché le case farmaceutiche dei “paesi civilizzati” in questo non trovano sufficiente interesse economico o possibilità di profitto, ma ciò non riguarda i migranti che riescono ad arrivare vivi in Italia, dal momento che le malattie veramente gravi uccidono chi è ammalato ben prima che questi metta piede sul suolo italiano e che tutti i casi di allarmismo sono stati poi sistematicamente smentiti dai fatti (dalla fantomatica emergenza tubercolosi al caso di vaiolo e all’ebola): come spiegato brevemente qui, «che gli immigrati portino malattie a rischio per l’Italia è una realtà infondata. In realtà molte malattie riemergono dal passato e sono globali». E, soprattutto, «viaggiano in aereo» e non sui barconi. E c’è anche da aggiungere che questa paranoia sarebbe molto più sensata rispetto alla circolazione delle merci, che possono veicolare topi, insetti o altri animali portatori di malattie esotiche, ma è risaputo che la circolazione delle merci non si tocca, in nome delle intoccabili sacre leggi di mercato.
Non so: – allontanandosi gesticolando – Razzista. fascista, nazista, negriero, egoista, bastardo, figlio di puttana, pezzo di m…a
Razzista: Ma cosa ho detto di così irragionevole?
E così, con le imprecazioni a casaccio del “non so” sotto lo sguardo divertito del razzista, si conclude la conversazione. Il razzista, con sorriso beffardo, sa di aver vinto la partita e si chiede cosa possa mai aver detto di tanto irragionevole da suscitare una tale reazione da parte dell’interlocutore che fino a quel momento si era mostrato tranquillo (ma anche un po’ scemo, detto tra noi). I ruoli dunque si riconfermano: la reazione finale del “non so” lo contraddistingue come irrazionale, mentre il razzista è dotato di capacità argomentative che lo fanno campione di razionalità.
A dire la verità, Grillo parla non di razionalità o irrazionalità, ma di ragionevolezza e irragionevolezza: il primo binomio pertiene alla logica, il secondo al buon senso (o al senso comune, che spesso razionale non è affatto). Razionale è chi, conforme alla ragione, conduce un discorso o attua un comportamento secondo un rigore logico; ragionevole è che si lascia guidare dalla ragione ed è pertanto equilibrato, coscienzioso, discreto, equo. Il razzista della conversazione si chiede, perplesso, cosa abbia detto di tanto irragionevole. Dunque ha la pretesa che le sue argomentazioni siano considerate non tanto razionali, quanto ragionevoli. Ovvero equilibrate, discrete, giudiziose ed equidistanti. A Ventimiglia equidistante dalle forze di polizia che schiacciano i profughi in una morsa di disperazione e chi vuole semplicemente attraversare il confine tra un paese e l’altro; nei centri di detenzione equidistante dai carcerieri e i carcerati; nel dibattito pubblico equidistante tra chi dice che i migranti sono da annegare tutti e chi dice che sono persone da salvare. Insomma, di fronte a maltrattamenti, violazioni, sfruttamento e discriminazione, il ragionevole razzista della conversazione ci dice che si deve essere equilibrati e discreti, non alzare la voce, non indignarsi, non odiare con tutto il cuore istituzioni, persone e atti che seminano odio, segregano e discriminano, si ergono a difesa dei confini lasciando morire migliaia di persone. Se qualcuno pensa di poter argomentare in buona fede che Grillo non è un cazzo di razzista di merda dopo questa volta è veramente solo un coglione.

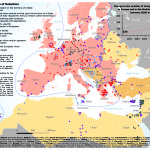 [clicca per ingrandire]
[clicca per ingrandire]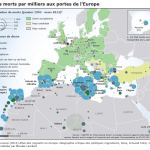 [clicca per ingrandire]
[clicca per ingrandire] A quelli che dicono «dopo questo voto le cose finalmente cambiano», «la base è migliore di Beppe Grillo» e dopo lo scetticismo degli ultimi mesi o anni cominciano a pensare al M5S come un possibile strumento parlamentare nella lotta contro la xenofobia o vedono possibili aperture da parte del M5S perché questo si affianchi al movimento contro il razzismo e per i diritti dei migranti, andrebbero tuttavia ricordate un paio di cose.
A quelli che dicono «dopo questo voto le cose finalmente cambiano», «la base è migliore di Beppe Grillo» e dopo lo scetticismo degli ultimi mesi o anni cominciano a pensare al M5S come un possibile strumento parlamentare nella lotta contro la xenofobia o vedono possibili aperture da parte del M5S perché questo si affianchi al movimento contro il razzismo e per i diritti dei migranti, andrebbero tuttavia ricordate un paio di cose.
 A questo “dispositivo psicologico” della discriminazione si aggiunga il vantaggio economico del razzismo: esso è funzionale al sistema di sfruttamento. Permette di formare e mantenere un sottoinsieme della classe lavoratrice in condizioni di ricattabilità e a bassissimo costo, con la comodità che tale suddivisione interna agli sfruttati può essere perpetuata senza l’uso di forza militare, ma semplicemente costruendo una narrazione razzista che assecondi una preesistente assuefazione alla marginalizzazione.
A questo “dispositivo psicologico” della discriminazione si aggiunga il vantaggio economico del razzismo: esso è funzionale al sistema di sfruttamento. Permette di formare e mantenere un sottoinsieme della classe lavoratrice in condizioni di ricattabilità e a bassissimo costo, con la comodità che tale suddivisione interna agli sfruttati può essere perpetuata senza l’uso di forza militare, ma semplicemente costruendo una narrazione razzista che assecondi una preesistente assuefazione alla marginalizzazione. Secondo questa stessa direzione, la discriminazione di razza spesso si rivela una forma di discriminazione di classe, che più che essere basata su caratteri etnici o razziali, trova in queste una legittimazione di facciata, mentre i criteri profondi di pregiudizio sono di carattere sociale (per esempio nel sempreverde «rubano»). In una società intrinsecamente gerarchica e discriminatoria, è prevedibile che chiunque discrimini chi nella gerarchia sta più in basso, e puntualmente ciò accade, ad esempio quando i poveri discriminano i poverissimi perché «loro sono sempre i primi della lista per l’assegnazione delle case popolari».
Secondo questa stessa direzione, la discriminazione di razza spesso si rivela una forma di discriminazione di classe, che più che essere basata su caratteri etnici o razziali, trova in queste una legittimazione di facciata, mentre i criteri profondi di pregiudizio sono di carattere sociale (per esempio nel sempreverde «rubano»). In una società intrinsecamente gerarchica e discriminatoria, è prevedibile che chiunque discrimini chi nella gerarchia sta più in basso, e puntualmente ciò accade, ad esempio quando i poveri discriminano i poverissimi perché «loro sono sempre i primi della lista per l’assegnazione delle case popolari».