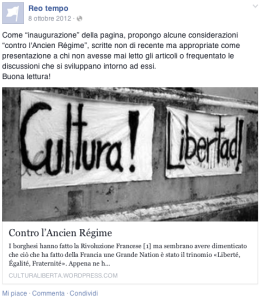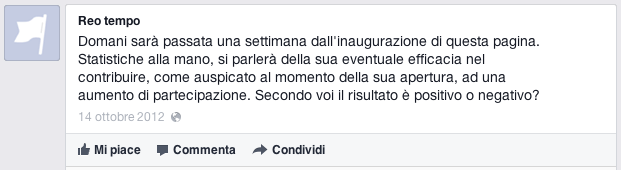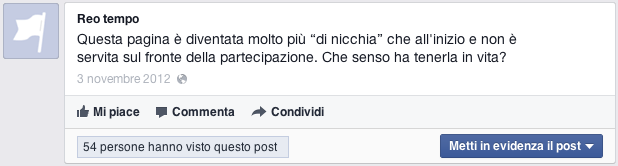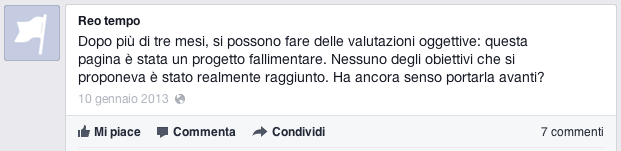Di chi è la responsabilità delle innumerevoli vite umane stroncate da naufragi su barchette instabili e sovraffollate nella pericolosa traversata del Mar Mediterraneo, ormai diventato tomba di migliaia e migliaia di esseri umani?
La Repubblica, nel suo importante ruolo di faro nell’orientamento dell’opinione pubblica nazionale, si fa carico delle necessità di esprimere il punto di vista della borghesia illuminata, ovvero tutta l’area della sinistra progressista e riformista (se ancora esiste qualcosa che così si possa definire), e alla domanda risponde senza dubbio alcuno, attraverso le parole di un Roberto Saviano secondo cui «quei morti di nessuno pesano sulle nostre coscienze», o attraverso non tanto i contenuti quanto il titolo scelto per le riflessioni di un Ilvo Diamanti, ovvero «dobbiamo avere pietà di noi». Si tratta di due esempi, ma si potrebbe continuare a lungo, citando i commenti indignati giornalisti, politici, semplici cittadini che si esprimono in rete per dire all’unisono, in un moto di indignazione, che noi dobbiamo vergognarci.
Come per le reazioni alla recente condanna dell’Italia per i fatti della Diaz, è opportuno analizzare di quale retorica sono sintomi queste manifestazioni di indignazione e di quali valori tale retorica è veicolo nella costruzione del dibattito pubblico.
Il leitmotiv delle reazioni di area progressista è la condivisione della colpa: «siamo tutti responsabili», «dobbiamo vergognarci», «questi morti pesano sulle nostre coscienze». Non si può notare una certa insistenza di un «noi» che, in mancanza di ulteriori specificazioni, comprende l’intera società italiana, europea o addirittura “occidentale”. Secondo questa retorica, ogni italiano deve sentirsi colpevole e responsabile per le morti che riempiono di cadaveri il Mar Mediterraneo. Un pensiero del genere non solo è non corrispondente a verità, ma è anche politicamente dannoso in quanto assume la funzione di strumento autoassolutorio: in conformità con la tradizione morale cattolica, si intende imporre un senso di colpa pervasivo che, in fondo, assolve tutti. Dal momento che, si sa, se «siamo tutti responsabili», se è colpa di tutti, non è più colpa di nessuno.
Ma davvero questo è soltanto un prodotto della morale cattolica? La redistribuzione della colpa non ha anche una funzione politica, più o meno consapevolmente contemplata da chi si unisce al coro degli autoflagellanti? L’impressione è che i giornalisti scrivano «siamo tutti responsabili» per non dover fare i nomi dei responsabili, perché attribuendo la colpa «agli italiani» si può evitare di attribuirla a quegli italiani che responsabili sono davvero, forse per paura di inimicarsi quei lettori che hanno votato la Lega Nord perché inventasse il reato di clandestinità e la legge Bossi-Fini, o quei lettori che hanno sostenuto ciecamente forze politiche favorevoli alle espulsioni, o quei lettori (e quei partiti) che dietro le mani tese e il sorriso affabile sul volto nascondono le chiavi delle prigioni note come CIE. Invece è più facile dire che la responsabilità è di tutti, senza indagare troppo.
La retorica autoassolutoria del «siamo tutti responsabili» funziona e bene, tanto che la usa pure Federica Mogherini, quale Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (ovvero il Ministro degli Esteri europeo) in occasione della riunione straordinaria tenutasi per discutere sulla gestione dei flussi migratori. Mogherini dice, infatti, che «la priorità è costruire un senso comune di responsabilità europea per quanto succede nel Mediterraneo». Che è un modo per dire “non è colpa mia”. Ovviamente, in quanto esponente di un partito che si erge a difesa del grande capitale, Mogherini non può certo attribuire le responsabilità a chi andrebbero attribuite. Per esempio, a quella classe dirigente americana che «è impegnata in una guerra continua nel tentativo di dominare le regioni ricche di petrolio del Medio Oriente, dell’Asia Centrale e del Nord Africa. Queste guerre hanno distrutto stati e intere comunità, con sofferenze umane indicibili, fomentato un abisso di odio e di terrore. Le classi dirigenti, i partiti politici e tutte le istituzioni ufficiali del capitalismo americano e europeo sono implicati in questo crimine storico, o perché difendono gli interessi imperialisti delle multinazionali e delle banche o per sostanziale acquiescenza» (da qui).
Di tanto in tanto, ma ormai sempre più insistentemente, la responsabilità è attribuita agli scafisti, questi traghettatori di anime, definiti «nuovi schiavisti» «trafficanti di schiavi» secondo il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, che vengono arrestati e i cui identikit finiscono in prima pagina sui maggiori quotidiani nazionali, perché è comodo trovare il capro espiatorio su cui far ricadere ogni disprezzo per ciò che avviene tra l’Africa e l’Europa. Come la precedente retorica autoassolutoria, anche questa è una strategia diversiva. Anche senza spingerci troppo lontano, è possibile rintracciare le reali cause delle stragi in mare già nella continuazione del discorso di Mogherini: «per l’Europa è imperativo salvare tutti insieme delle vite umane, così come tutti insieme dobbiamo proteggere i nostri confini e combattere il traffico di esseri umani». Qualcuno dovrebbe spiegare a Mogherini (o forse lo sa già fin troppo bene) che le stragi avvengono a causa dei confini, che gli scafisti e il traffico di esseri umani non esisterebbe se “noi” non proteggessimo i “nostri” confini e che dunque non si può allo stesso tempo invocare la difesa dei confini e la necessità di prevenire le stragi. Le stragi si prevengono smettendo di “proteggere” le frontiere, abbandonando l’idea della sacralità dei confini, peraltro già sconsacrati dall’ordine neoliberista.
In effetti, questo è chiedere troppo. Stiamo parlando di gente che scrive “noi” per riferirsi agli italiani e “nostri” per riferirsi ai confini. E quel pronome e quell’aggettivo, tanto cari ai nazionalismi, agli identitarismi e ai fascismi novecenteschi, già da soli bastano a rafforzare, piuttosto che abbandonare, la sacralità dei confini.