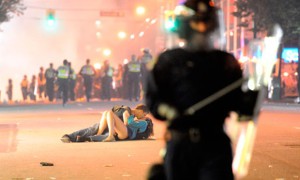Un articolo del 1 marzo 2016 su La Repubblica riporta le dichiarazioni di Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’ENI, interpellato da Amnesty Inernational in merito al caso Regeni e alle polemiche sugli affari d’oro che la compagnia sta facendo in Egitto con il beneplacito del Presidente della Repubblica egiziano Abd al-Fattah al-Sisi nonostante si tratti di un dittatore insediatosi al potere tramite colpo di Stato militare e accusato di sistematiche violazioni dei diritti umani.
La richiesta di Amnesty International e della famiglia Regeni all’ENI è di sfruttare la sua posizione di interlocutore privilegiato con il governo egiziano, in virtù degli accordi commerciali sull’energia, per esercitare pressioni affinché le autorità egiziane conducano una seria inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. «Aiutateci, vista la vostra presenza nel Paese e gli accordi commerciali, a spingere le autorità egiziane a chiarire al più presto le circostanze dell’omicidio e ad accertarne le responsabilità».
La pronta riposta dell’ENI è stata: «Le risposte che la famiglia Regeni attende sono risposte importanti anche per noi, perché il rispetto di ogni persona è alla base del nostro operare e perché siamo impegnati nello sviluppo. Abbiamo fiducia nel lavoro che si sta facendo da parte dei governi egiziano e italiano».
Come è evidente a chiunque, da questa risposta si evincono tre cose. Uno: che la verità sul caso Regeni è importante per l’ENI. Due: che il rispetto di ogni persona è alla base della sua politica aziendale. Tre: che l’ENI ha motivo di riporre fiducia nelle indagini in corso per appurare la verità. Ciascuna di questre tre frasi è falsa.
1. «Le risposte che la famiglia Regeni attende sono risposte importanti anche per noi»
Nelle settimane che hanno seguito il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni (avvenuto il 4 febbraio 2016), le autorità egiziane nonostante l’imbarazzo hanno rassicurato l’Italia, preoccupata per gli interessi di importanti aziende italiane in Egitto, che il caso diplomatico non avrebbe compromesso gli investimenti e gli accordi commerciali. In risposta, l’Italia, come sottolineato da un funzionario, ha ribadito che «nessuno da parte italiana vuol mettere in discussione le intese sulle quali stiamo lavorando: dal punto di vista tecnico, l’omicidio e le relazioni economiche sono due questioni scollegate». E infatti, il ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie egiziano ha approvato l’assegnazione all’ENI del “contratto di sviluppo di Zohr” che garantisce la possibilità dell’ENI di sfruttare «il più grande giacimento di gas mai rinvenuto nel Mediterraneo», al largo delle coste egiziane, confermando l’avvio dei lavori per l’estrazione (l’inizio della produzione è previsto entro la fine del 2017) in vista di una produzione a regime di circa 75 milioni di metri cubi standard di gas al giorno (equivalenti a circa 500 mila barili di olio equivalente al giorno) entro il 2019. Il 26 febbraio l’ENI ha annunciato con soddisfazione «nuovi successi esplorativi in Egitto»: «recentemente Eni ha annunciato di aver completato con le autorità egiziane il processo autorizzativo per lo sviluppo del giacimento di Zohr».

Qualcuno potrebbe obiettare: e questo cosa c’entra? Non può Claudio Descalzi, a prescindere dalle frequentazioni che intrattiene e dagli affari commerciali che cura in Egitto, manifestare vicinanza umana nei confronti della famiglia di Giulio Regeni e ritenere importanti le risposte dovute a chi chiede verità e giustizia?
Certo, può farlo in quanto Claudio Descalzi; ma bisogna ricordare che Claudio Descalzi ha rilasciato questa dichiarazione in qualità di amministratore delegato, e dunque rappresentando non tanto il proprio interesse di singolo cittadino, quanto piuttosto l’interesse dell’azienda di cui è amministratore delegato (infatti dice «importanti per noi»). Quando dice che le risposte che la famiglia Regeni attende sono importanti, Claudio Descalzi non parla a nome di Claudio Descalzi, ma a nome dell’ENI. E per l’ENI tali risposte non sono in alcun modo importanti, giacché l’ENI in quanto azienda ha un unico interesse strutturale: il profitto. Un profitto di cui è stato limpidamente ammesso che non sarà intaccato dagli sviluppi di questa torbida vicenda. E soprattutto, da questa posizione emerge che l’ENI non ha intenzione di esercitare pressioni sulle autorità egiziane perché si faccia luce sulla verità di quanto è accaduto: le risposte che la famiglia Regeni attende sono importanti, ma l’ENI non c’entra nulla.
2. «Il rispetto di ogni persona è alla base del nostro operare»
Per l’ENI fare affari con dittatori e assassini, e dunque legittimarli, non è cosa nuova.
Il sito ufficiale riporta una lista dei paesi in cui l’azienda opera attualmente, con in cima Arabia Saudita, Iran, Libia, Egitto, Kazakistan, Turchia, Nigeria, tutti paesi i cui governi si macchiano di violenze sistematiche nei confronti di almeno una parte della popolazione, con scarso rispetto dei diritti umani, come denunciato da Amnesty International e l’Osservatorio per i Diritti Umani presso l’ONU. Avere a che fare con certi soggetti riconoscendoli come validi interlocutori per discutere di affari significa dar loro legittimità politica, per quanto, si potrebbe dire, l’ENI non è coinvolta direttamente nelle violazioni perpetrate dai regimi in questione.
Eppure, anche volendo scagionare l’ENI dall’accusa di non rispettare indirettamente i più basilari diritti, ci si troverebbe presto di fronte a un problema: l’ENI stessa direttamente viola basilari diritti. Come quelli sindacali, quando a Zhanaozen, in Kazakistan, per sei mesi gli operai di un industria petrolifera del gruppo ENI scioperarono per chiedere migliori condizioni di lavoro e l’unica cosa che ottennero, a parte il rifiuto di ogni trattativa, il licenziamento degli operai sindacalmente più attivi, le minacce e le aggressioni fisiche, furono le pallottole della polizia che uccise dodici di loro, nel contesto di una repressione generale dei lavoratori del petrolio che fece almeno un centinaio di morti; o quelli alla salute e all’autodeterminazione, dal momento che in Nigeria l’ENI e le sue consociate, come tutte le altre compagnie petrolifere presenti su quel territorio, sono responsabili di devastazione ambientale, avendo contaminato con fuoriuscite dagli oleodotti falde acquifere, corsi d’acqua, foreste, formazioni a mangrovie e campi coltivati dai quali le comunità locali traggono il proprio sostentamento; nello stesso Paese l’ENI pratica il gas flaring, un processo fortemente inquinante per l’atmosfera; tutto questo è stato fatto scontrandosi con le popolazioni pocali del Delta del Niger la cui protesta è stata repressa nel sangue da milizie private aziendali o dall’esercito regolare nigeriano dietro lauto compenso delle compagnie petrolifere. La quantità di operazioni irrispettose dell’ambiente, della salute e dei diritti di interi popoli è tale da costituire materiale sufficiente per un costante lavoro di aggiornamento e controinformazione condotto da un sito apposito. Si ha ben ragione di nutrire qualche dubbio sull’affermazione di Descalzi secondo cui «il rispetto di ogni persona è alla base» delle azioni dell’ENI.

Fa un certo effetto leggere uno degli slogan pubblicitari dell’ENI, che recita «l’energia è una bella storia», proprio accanto ad un’articolo di Nicholas Newman pubblicato sul sito ENI dal titolo Un esercito sostenibile, che elogia le virtù del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, «il più grande consumatore di energia e petrolio al mondo» ma anche impegnato, ultimamente, a ridurre le spese, risparmiare energia e investire maggiormente nelle energie alternative». Si va dalla sperimentazione di «motori adattativi» per ottimizzare il consumo di carburante all’uso di sistemi di propulsione ibridi per i veicoli militari. Tra le altre cose, «vengono anche testate docce che riciclano l’acqua per successivi usi, per lavarsi o lavare i panni. Dispositivi che possono essere alimentati da batterie solari o celle a combustibile compatte riescono a far funzionare i climatizzatori, le comunicazioni, i computer e i sistemi elettrici ausiliari sul campo, migliorando la qualità della vita e la sicurezza».
Forse l’articolo di riferisce alla qualità della vita dei pazienti dell’ospedale MSF di Kunduz, in Afghanistan, bombardati e uccisi il 3 ottobre 2015 dagli aerei NATO, o forse alla sicurezza dei pazienti dell’ospedale di Erbin, in Siria, colpiti il 23 novembre 2015 da missili sulla cui provenienza nessuno ha fatto luce. L’esercito elogiato dall’articolo dell’ENI è coinvolto in decine di missioni militari in tutto il mondo, che provocano morte, sfollati, distruzione anche per assicurarsi il controllo dell’energia. Un’energia che non è dunque «una bella storia», almeno non proprio bella come l’ENI vorrebbe dipingerla.
Insomma, per l’ENI la guerra è bella se si rispetta l’ambiente (ammesso poi che una divisione di carri armati ibridi che fa saltare in aria un pozzo di petrolio strategico sia meno dannoso per l’ambiente di, per esempio, una normale divisione di carri armati che fa saltare in aria lo stesso pozzo di petrolio strategico). La riduzione dell’inquinamento giustifica e rende accettabile, preferibile e quasi desiderabile la guerra pulita. Non dovremmo prevenire le guerre od opporci ad esse, dovremmo continuare a farle usando armi biodegradabili. Speriamo che i missili che hanno colpito l’ospedale di Erbin fossero rispettosi dell’ambiente.
3. «Abbiamo fiducia nel lavoro che si sta facendo da parte dei governi egiziano e italiano»
È alquanto singolare che qualcuno, di chiunque si tratti, possa essere fiducioso nel comportamento del governo egiziano per lo svolgimento delle indagini sulla morte di Regeni. Il governo egiziano attualmente in carica si è insediato con un colpo di Stato militare il 3 luglio 2013 deponendo il presidente Muhammad Morsi legittimamente eletto nelle elezioni del 2012, le prime dopo la Rivoluzione Egiziana del 2011 che aveva posto fine alla dittatura di Mubarak.
Fin dall’insediamento, il governo egiziano si è reso responsabile di arresti arbitrari in massa di decine di migliaia di persone, detenzioni illegali, orribili episodi di tortura e decessi in custodia di polizia. Un mese dopo il colpo di Stato militare, il governo inaugurava la repressione di massa con il massacro di 638 persone, il 14 agosto 2013, e la successiva messa al bando dell’opposizione e condanna a morte di circa 1.200 dei suoi dirigenti. In un articolo pubblicato da Il manifesto l’estate scorsa, si conta che dal febbraio 2014 al gennaio 2015 sono state 415 le persone condannate a morte in processi di massa e spesso irregolari. In altri casi, come quello dello studente Ahmed Hussein, si è ricorso a una detenzione indefinita, senza processo e senza accusa. Al 2016 sono 3.000 i condannati a morte.
Secondo Reporter Senza Frontiere, l’Egitto è oggi il secondo paese al mondo per numero di giornalisti imprigionati. In un clima del genere, come si può pensare che le indagini per accertare la verità, che fanno sempre più pensare ad un coinvolgimento diretto dei servizi segreti egiziani, possano svolgersi con correttezza e imparzialità e senza condizionamenti politici ed influenze da parte delle autorità egiziane per insabbiare e depistare?
E inoltre, come si può pensare che il governo italiano eserciti efficacemente pressioni per l’accertameno della verità, alla luce degli enormi interessi economici italiani in Egitto e soprattutto dopo le numerose volte in cui si è mostrato accondiscendente e compiacente anche sul piano politico?

Nel 2014 Renzi accolse al-Sisi a Roma come colui che avrebbe collaborato a sconfiggere «terrorismo e radicalismo grazie alle scuole e all’educazione», dimenticando che le scuole e le università egiziane erano ormai militarizzate, presidiate dai servizi segreti e soggette a continue incursioni dell’esercito per arresti di massa e repressione del dissenso; nel luglio 2015, quindi dopo che la ferocia repressiva e sanguinaria del regime egiziano era già nota da tempo, Matteo Renzi definì il dittatore egiziano «un grande leader» e «l’unica speranza per l’Egitto»; il sostegno è stato ribadito ancora da Renzi proferendo al dittatore, definito «un grande statista» che detiene «il merito di aver ricostruito il Mediterraneo» (ma che cazzo significa?), le parole «La tua guerra à la nostra guerra, e la tua stabilità è la nostra stabilità»; la lista di complimenti si allunga fino ad arrivare al 18 gennaio 2016, appena due settimane prima del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, quando Renzi definì i rapporti con l’Egitto «eccellentissimi».
«Altri leader di altri paesi occidentali, che pure hanno rapporti amichevoli con l’Egitto, non si sono spinti a usare parole tanto celebrative per al Sisi», spiega Stefano Torelli, ricercatore dell’ISPI. Forse questo è sintomo della tradizionale tendenza delle istituzioni italiane all’amore per la pomposità cerimoniale e all’incensamento chi sembra avere la meglio, cambiando di volta in volta ala sotto cui accomodarsi (o culo su cui spalmare la lingua).
L’indiscutibile sostegno politico manifestato dall’Italia al dittatore egiziano è garanzia di copertura e impunità; il governo italiano è complice di quel senso di impunità che consente ai servizi di sicurezza di torturare e di uccidere senza che questo abbia ripercussioni. E né all’Italia né all’Egitto conviene che ci siano ripercussioni di sorta: gli interessi commerciali e geopolitici in gioco sono talmente imponenti (ricorda Marina Forti che circa 130 aziende italiane operano in Egitto, in particolare in settori come finanza, cemento, turismo, energia, trasporti, logistica) che qualche decina di migliaia di arresti, la repressione del dissenso, la violazione dei diritti umani, migliaia di morti sono un equo prezzo da pagare. Risulta difficile pensare che in questo prezzo non sia inclusa anche la docilità e la mancanza di determinazione nell’accertare verità pericolosamente scomode.
Conclusione
Rileggiamo dunque la dichiarazione rilasciata dall’ENI in risposta alla richiesta di intervenire come interlocutore privilegiato per esercitare pressioni sulle autorità egiziane.
«Le risposte che la famiglia Regeni attende sono risposte importanti anche per noi, perché il rispetto di ogni persona è alla base del nostro operare e perché siamo impegnati nello sviluppo. Abbiamo fiducia nel lavoro che si sta facendo da parte dei governi egiziano e italiano».
Traducendo: no, non eserciteranno pressioni per ottenere risposte, e perché dovrebbero? Del resto, tutte le volte che l’ENI ha esercitato pressioni sulle autorità di questo o quel paese è stato per reprimere le lotte sindacali, come in Kazakistan, o la resistenza delle popolazioni locali, come in Nigeria. Mai per ottenere verità, sempre per nasconderla o ricacciarla nell’angolo dei vinti.
Per finire, è da notare un’ultima cosa. Un altro elemento significativo è che La Repubblica abbia scelto di pubblicare questo scambio senza alcun commento che possa riportare alla mente le responsabilità che l’ENI ha e ha avuto con regimi dittatoriali: di fatto, nel limitarsi semplicemente a riportare il virgolettato dell’amministratore delegato, pare che la notizia nasca più dalla volontà di dare all’ENI una patina di credibilità e impegno per i diritti umani che di produrre un’informazione completa come quella che una testata nazionale dovrebbe essere tenuta a fornire. Il fatto che La Repubblica sia finora l’unico giornale a tiratura nazionale ad aver riportato, tra l’altro con dubbia imparzialità, le dichiarazioni di Descalzi (facendone una notizia con tanto di titolo sulla home del sito) è insolito e rende ancora più sospetta l’ambiguità dell’articolo. Oppure, con meno malizia, occorre accettare il fatto che, come accade fin troppo spesso, siamo soltanto di fronte a un esempio di giornalismo raffazzonato e poco professionale (a voler essere buoni).