Lo scorso dicembre, il podcast francese di ecologia politica Le monde d’après ha intervistato Alessandro Pignocchi, militante del movimento dei Soulèvements de la Terre conosciuto nei mesi successivi per aver organizzato la manifestazione del 25 marzo 2023 a Sainte-Soline. Ho trascritto, riadattato e tradotto l’intervista nel testo qui sotto, che è stato pubblicato su Jacobin Italia.
Il 21 giugno, il governo francese ha ufficializzato la procedura di scioglimento dei Soulèvements de la Terre, movimento ecologista radicale, conflittuale e di massa che conta più di 140.000 simpatizzanti e quasi 200 comitati locali, assurdamente accusato di «ecoterrorismo» nel contesto della spirale repressiva degli ultimi mesi che ha visto un inquietante deterioramento della libertà di espressione, segnalato anche dall’Onu. Il movimento, nato nel 2021, è stato all’origine di decine di azioni dirette di massa negli ultimi due anni (occupazioni di terre, sabotaggi, «disarmo» di impianti e stabilimenti nocivi per l’ambiente) ed è stato capace di federare attorno a obiettivi materiali e concreti una grande rete di associazioni, collettivi, sindacati, gruppi militanti, personalità del mondo culturale, intellettuale e artistico.
Alessandro Pignocchi è uno di questi: fumettista con un passato da ricercatore in scienze cognitive e sociali, ha scritto di recente, insieme all’antropologo Philippe Descola, il «saggio illustrato» dal titolo Ethnographie des mondes à venir. Il podcast francese Le monde d’après, che si occupa di questioni legate all’ecologia politica, lo ha intervistato. In questa traduzione si toccano le principali idee politiche e strategiche dietro alle pratiche di azione diretta del movimento ecologista in Francia.
Nel libro, appoggiandovi all’antropologia, dite che il sistema oggi egemonico, il capitalismo con gli Stati-nazione, è un incidente di percorso nella storia dell’umanità.
Le strutture in cui si cresce, si riceve un’educazione, si vive, tendiamo a considerarle universali e indiscutibili, e spesso non abbiamo neanche gli strumenti per riflettere su di esse. L’esempio più classico di cui parla l’antropologia è la distinzione tra natura e cultura, l’idea che esiste qualcosa là fuori, chiamata natura, che sia una realtà oggettiva distinta chiaramente dalla cultura e dalle attività umane. Solo osservando quanto mostrato da studiosi e da popolazioni che si organizzano in tutt’altro modo, che non hanno nemmeno un vocabolo per esprimere ciò che noi chiamiamo «natura», ci si accorge che le cose potrebbero essere differenti.
Un’idea è pensabile e criticabile solo se si riesce a immaginare il suo contrario: ciò è vero per la distinzione natura-cultura, ma anche per lo Stato-nazione o il capitalismo. Per fortuna esistono la storia, l’antropologia, l’archeologia, tutte discipline la cui funzione è dare a una società la percezione della relatività dei propri valori, del fatto che le strutture potrebbero essere diverse. Non sono semplici esercizi di immaginazione, ma forme di organizzazione sperimentate di fatto da altri popoli altrove nel mondo o in altri momenti della storia.
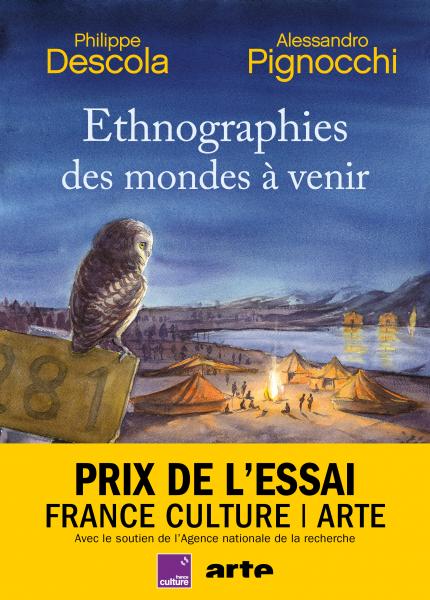
Nel libro chiamate «naturalismo» la distinzione tra natura e cultura. Perché è un problema distinguere cultura e natura?
Non è necessariamente un problema in sé. Il problema è che distinguere nettamente le società umane dagli altri esseri viventi e dai fenomeni naturali, e soprattutto attribuire a questi ultimi uno statuto di oggetto, ha avuto magari alcuni risvolti positivi (per esempio ha dato un impulso allo sviluppo delle scienze moderne) ma anche un certo numero di inconvenienti: è infatti una condizione dello sfruttamento e della devastazione capitalista del mondo, poiché crea una vasta categoria di oggetti da cui si può attingere risorse e materiale senza alcuna remora, senza alcun dovere di reciprocità. Si tratta di un comportamento che alla scala della storia dell’umanità è estremamente insolito: gli altri popoli del mondo non tendevano a considerare gli esseri non umani come materia inerte. Questo è il problema contingente della crisi ecologica: non la distinzione tra natura e cultura, ma le idee che la presuppongono, che si materializzano in istituzioni e fatti sociali. Esistono poi altri problemi, in particolare la povertà dei modi di relazione che produce nei confronti di piante, animali e luoghi di vita: o li si sfrutta, considerandoli come risorse, o li si protegge, ma la protezione «all’occidentale» è anch’essa un modo di relazione relativamente povero che si limita più o meno alla contemplazione estetica, e in ogni caso li si considera come oggetti il cui valore deriva dai servizi che possono renderci.
Nei rari luoghi dell’Amazzonia in cui il capitalismo e il naturalismo non sono ancora penetrati profondamente, le piante e gli animali sono considerati soggetti, esseri con una propria interiorità, e dunque i modi di relazione con essi sono relazioni sociali: con loro si discute, si patteggia, ci si sente in dovere di reciprocità; tutte le attività di sussistenza come caccia, raccolta, agricoltura, si realizzano secondo modi di relazione diplomatici: si devono continuamente risolvere conflitti d’uso, morali, negoziando in maniera più o meno ritualizzata per andare d’accordo con i coabitanti non umani. In termini di rappresentazione, d’emozione, di coinvolgimento sono molto più ricchi di una semplice relazione d’uso, il che apre a maniere di stare al mondo più intense e felici rispetto a quando ci si limita al semplice sfruttamento o alla contemplazione.
Noi non sosteniamo ovviamente che si debba diventare animisti come i nativi dell’Amazzonia, ma che si debba abitare il mondo secondo istituzioni, differenti dalle nostre, che ci porterebbero a tenere spontaneamente conto degli interessi della foresta, delle praterie, degli animali di allevamento, eventualmente degli animali cacciati, degli animali selvatici e di quelli domestici. Il punto è politicamente importante perché se si critica il naturalismo, nel senso di natura oggettificata, in cui i soggetti sono dalla parte delle società umane, solo quando si criticano le responsabilità umane per la crisi ecologica si entra in azione per «evitare il peggio»; invece è molto più forte lottare non per evitare il peggio, ma per andare verso un meglio. Sono modi d’azione più forti di quando si reagisce semplicemente all’ansia e alla paura della catastrofe.
Come si possono avere relazioni diplomatiche con persone che non sono della nostra stessa specie?
Non è scontato per noi che viviamo in un mondo in cui la diplomazia è un fatto sociale e il sociale riguarda esclusivamente gli esseri umani, ma dopo tutto l’idea non è così assurda. Nel luogo a cui ci ispiriamo, la ZAD di Notre-Dame-des-Landes, si può dire che in generale chi ci abita mantiene delle relazioni diplomatiche con gli esseri non umani: quando si tratta di scegliere quale albero tagliare nella foresta di Rohanne, si pensa agli interessi delle attività agricole, al bisogno di legno, ma anche e altrettanto seriamente a questioni di rigenerazione della foresta, per esempio facendo spazio per permettere la ricrescita di altre specie, per creare una maggior diversità e una foresta più ricca; quando chi alleva si chiede su quale prato far pascolare le pecore, le sposta dove il giunco comincia a invadere e trasformarsi in foresta; e lo stesso vale per il modo di trattare gli animali allevati. Magari il termine «diplomazia» è un po’ pesante, ma sono gli interessi di questi esseri in quanto soggetti a essere spontaneamente presi in considerazione. Per noi, le piante coltivate e gli animali allevati sono pura risorsa, sono «animali-materia» per dirla con Charles Stépanoff, e le piante sono ancora più oggettificate. Al contrario presso altri popoli fin dalla prima infanzia si ascoltano i racconti dei genitori, si osservano comportamenti in cui le piante coltivate, per esempio, sono considerate dalle donne come dei figli. Esistono tanti altri modi di interazione molto più sofisticati, tanto con gli animali cacciati nella foresta quanto con le piante coltivate: sono interlocutori con i quali si discute, si tratta. Ovviamente noi non proponiamo di metterci a credere che le pecore e gli alberi della foresta di Rohanne possano venire a trovarci in sogno per chiederci questo o quello, ma di costruire un ambiente in cui le attività umane di abitazione, di sussistenza, siano pensate collettivamente considerando gli interessi degli esseri non umani con cui coabitiamo, formulati ed espressi dalle persone che sono a diretto contatto con la foresta e con le greggi. Non si può conoscere con precisione cosa sia l’interesse di un albero o di una pecora, ma esistono a grandi linee direzioni che si possono immaginare, senza prendere troppi rischi, come buone e da favorire. Per esempio, il criterio della diversità: una foresta non tende mai da sola alla monocoltura, l’interesse di un ecosistema è di essere più diverso possibile.

Affermate nel libro che anche se a volte abbiamo dei rapporti affettivi con soggetti non umani, per esempio parlando con un gatto, un uccellino o una pianta, ciò «non viene istituito». Come si può andare verso un’istituzionalizzazione?
Nella nostra società, anche se esiste una legittimazione della relazione con gli animali domestici, quest’ultima costituisce un’eccezione: effettivamente con loro si discute, si hanno rapporti empatici, ma in generale le istituzioni su cui si articolano le grandi dimensioni del nostro rapporto col mondo, in particolare le nostre attività di sussistenza, sono estremamente oggettificanti. L’agricoltura industriale che nutre la maggior parte di noi non si pone certo la questione dell’interiorità degli esseri non umani. La tendenza generale che consiste ad attribuire un’interiorità a piante e animali, che manifestiamo soprattutto con gli animali domestici e che i bambini hanno molto più forte degli adulti, è qualcosa che crescendo impariamo a inibire, perché in generale in Occidente abbiamo plasmato istituzioni oggettificanti e non solo rispetto agli esseri non umani ma anche rispetto agli esseri umani. Le istituzioni economiche sono la forza oggettificante per eccellenza: per una struttura come il nostro mondo, dominato dalle regole del gioco economico, ogni essere, ogni ora di lavoro, ogni oggetto deve poter entrare nel mercato con un valore numerico, un valore di mercato, ed essere scambiato con qualunque altro oggetto. Si possono scambiare solo degli oggetti: a partire dal momento in cui ti accordo un’interiorità, non sei più scambiabile con un’ora di lavoro o con un oggetto o con una somma di denaro. Per un bambino che cresce in una grande città all’inizio è senza dubbio un po’ strano passare le giornate a scavalcare persone senza fissa dimora come se fossero meri ostacoli. Lo stesso vale per qualunque imprenditore o dirigente politico: imparano a oggettificare, devono inibire le proprie facoltà soggettivanti per trattare gli esseri umani che dominano come semplici oggetti, parametri di un’equazione senza un’interiorità. Vediamo lo stesso con l’allevamento: molti piccoli allevatori si avvicinano al mestiere per avere relazioni ricche e dense con gli animali, ma presi nella morsa del gioco economico hanno un vincolo di profitto, devono ingrandirsi e rendicontare e a poco a poco devono maltrattare gli animali e inibire sempre di più le facoltà empatiche che li avevano spinti all’inizio a entrare in quella attività, fino a trovarsi in un rapporto puramente oggettificante. Cito nel libro un allevatore di vacche che una volta oltrepassate le cinquanta vacche ha smesso di chiamarle per nome, per non impazzire.
Come cambiare queste istituzioni non è affatto scontato: strutturano praticamente tutto il nostro mondo da almeno due secoli. La sfera economica, il fatto che l’insieme delle nostre scelte sia determinato da questioni di profitto, è la prima cosa di cui disfarsi. Nella ZAD di Notre-Dame-des-Landes attraverso il mutualismo, la pratica dei beni comuni e l’attuazione di una forma di autonomia alimentare e politica, la morsa della sfera economica si allenta e ci si può offrire il lusso di pensare l’insieme delle attività che organizzano il territorio non più secondo criteri di profitto economico ma secondo ciò che si decide collettivamente in assemblee generali, considerando come soggetti non solo gli altri esseri umani ma anche gli esseri non umani, integrando i loro interessi alle decisioni collettive. L’esercizio di fantapolitica che proponiamo è di moltiplicare i territori di questo tipo. Appena si allenta un po’ la morsa dell’economia, è abbastanza ovvio considerare tutti gli altri esseri che abitano il territorio come co-abitanti, interlocutori, compagni di oppressione oggettificati dalle stesse forze statali e capitaliste: si hanno nemici comuni e solidarietà comuni.

Vorrei rimanere su quanto hai detto sull’economia. Nel libro, parlate di supremazia della sfera economica. Potresti spiegare cosa intendete dire?
Sul piano materiale è semplicemente la creazione di un mercato del lavoro da parte della borghesia, dunque la proletarizzazione della popolazione. Il primo ingranaggio, la base perché si abbia un proletariato che metta la propria forza lavoro a disposizione della borghesia, è che la popolazione che lo forma abbia perso le condizioni della propria autonomia.
Ci sono molti modi che gli Stati hanno usato e continuano a usare. Il principale è la privatizzazione della terra: quella terra che le popolazioni erano solite usare come bene comune, attingendo collettivamente a un insieme di risorse che permettevano loro di vivere. Dal momento in cui si disse «questo non vi appartiene più, a partire da oggi dovrete pagare per accedere o disporre della terra», non si ebbe più altra scelta se non andare a vendere la propria forza lavoro. Ci sono mille modi come questo usati per proletarizzare la popolazione. Nel corso del XVIII secolo, i fatti economici si distaccano e acquisiscono autonomia rispetto ad altri fatti sociali; allo stesso tempo, gli economisti e i filosofi teorizzano la creazione di una disciplina, l’economia, come sfera autonoma, un insieme di fatti sempre più indipendenti che assumono una posizione dominante sul resto della vita sociale: esiste il mercato, che si concepisce come dotato di vita propria, e i suoi alti e bassi determinano le decisioni politiche. Oggi si giustificano leggi oppressive, di impoverimento, perché sono al servizio del buon funzionamento economico del paese e della crescita: ecco la sfera economica che domina sul resto della vita sociale. Rimetterla al servizio della vita sociale significa tornare a sottomettere, com’è stato nella storia dell’umanità, tutte le decisioni che riguardano la sussistenza, l’abitazione, il vivere insieme, non a regole economiche astratte ma a decisioni collettive, decisioni politiche: ovvero, sottomettere l’economia alla politica.
Parlate anche dell’idea di compensazione ecologica, secondo cui se si vuole distruggere un territorio, per esempio cementificandolo, bisogna compensare piantando degli alberi altrove.
Questo è ciò che si chiama commensurabilità generalizzata: ogni cosa è commensurabile, cioè può essere schiacciata su un asse di valore unico secondo cui tutto si può scambiare. In un mondo economicizzato se distruggi un ecosistema da qualche parte ma poi costruisci altrove qualcosa di valore equivalente, allora va tutto bene. Ciò significa che i legami affettivi di una popolazione con quell’ecosistema non hanno alcun valore. Infatti, perché esista la compensazione ecologica, è necessario che la totalità dell’ambiente e dei suoi abitanti non umani siano degli oggetti, per poterli scambiare con altri oggetti a cui si attribuisce pari valore… ma ovviamente per una popolazione che è cresciuta lì, che ha intessuto dei legami affettivi e magari, come nel caso delle popolazioni indigene, dei legami simbolici estremamente forti, dire «sì, la distruggiamo, ma niente paura: ne costruiamo un’altra altrove» non ha assolutamente senso, sarebbe come dire «prendiamo un vostro familiare, ma niente paura: lo sostituiamo».
Nel mondo a cui aspiriamo, non esiste uscita dalla crisi ecologica senza disfare queste istituzioni oggettificanti, in particolare quelle economiche. Si devono invece costruire collettivamente e con forza delle istituzioni soggettivanti. In un mondo del genere, la compensazione ecologica diventa qualcosa di completamente assurdo.
Nel libro constatate il sentimento di impotenza politica di responsabili di Ong che non vedono più a cosa serve ciò che fanno, ma allo stesso tempo criticate l’idea di un capovolgimento rivoluzionario che non vedete all’orizzonte. Proponete una specie di sistema misto in cui ci sarebbero degli Stati ma anche delle comunità autonome.
Le Ong e tutto il mondo dell’associazionismo si sono sviluppate sotto la socialdemocrazia, che è stata un periodo assai particolare: alla fine della Seconda guerra mondiale, per molteplici ragioni molto contingenti, le classi dominanti sono state inclini a fare concessioni. Bisogna prendere atto della fine di quel periodo: la socialdemocrazia ha essa stessa liberato le mani del capitale e sdoganato la possibilità dei movimenti internazionali di capitale. L’idea che l’argomentazione e la disamina scientifica possano influire sulle decisioni delle classi dirigenti deve semplicemente essere abbandonata, soprattutto ora che la crisi ecologica accresce ogni giorno gli antagonismi di classe: le classi dirigenti si sentono minacciate, pensano a mettersi al riparo e non certo a condividere le ricchezze.
Un altro problema è l’idea relativamente diffusa che bisogna sensibilizzare più gente possibile. Ovviamente è sempre ottimo riuscire a sensibilizzare, ma oggi la priorità non è questa: ci sono persone sensibilizzate a sufficienza, che soffrono del proprio lavoro di merda completamente assurdo, privo di senso, distruttivo… la consapevolezza e il desiderio di trovare altri modi di sostentamento, non distruttivi e che permettano di avere relazioni più piene con gli altri esseri umani o non umani non mancano.
Resta il capovolgimento rivoluzionario, il grande evento, e va benissimo continuare a pensarlo. Esistono tuttavia ragioni di dubitare della sua possibilità vista la potenza militare degli Stati e a che punto siamo diventati incapaci di organizzarci collettivamente. Abbiamo tutto da reimparare e l’idea di spazzare via le istituzioni per ricostruirle a tavolino, insieme, in armonia, sembra una prospettiva politica perlomeno azzardata. Provare a pensarci resta fondamentale, ma riteniamo che non possa essere l’unico orizzonte politico. Proponiamo una via alternativa che in effetti non è incompatibile con l’idea del grande evento: riprendersi i territori sfidando i modi di gestione della classe dominante, proponendo pratiche di organizzazione differenti. Invitiamo a pensare alle trasformazioni che tali territori autonomi potrebbero comportare per lo Stato. Non diciamo affatto che si dovrà segregare il territorio e che ci saranno da un lato territori autonomi che fanno la propria vita e dall’altro Stati che continueranno a esistere esattamente come prima. Diciamo che uno Stato che si trova, per un motivo o per l’altro, a dover convivere con dei territori autonomi non è più lo stesso Stato, perché i territori autonomi non sono compartimenti stagni, la popolazione si muove. Basandoci sull’antropologia e la storia recente, vediamo che in una vasta zona dell’Asia del Sud-Est la coabitazione tra Stati e territori organizzati ai loro margini era tipica, e negli ultimi 20.000 anni della storia dell’umanità questa era una situazione estremamente normale. Dei territori autonomi offrirebbero alle popolazioni che vivono sul territorio dello Stato una sorta di piano B: un altro modo di sostentarsi, di abitare, di nutrirsi, di vivere in società all’infuori dello Stato. Questo conferisce un potere di negoziazione, dei margini di manovra, che purtroppo l’organizzazione e la solidarietà operaia non riesce più a ottenere dagli anni Settanta quando gli Stati sono riusciti a distruggere il mondo del lavoro, a stroncare sul nascere ogni tentativo di sperimentare una potenza collettiva. Il tentativo di riprendersi le terre e di organizzarvisi diversamente è un’arma relativamente nuova che per adesso gli Stati gestiscono meno bene, per esempio, dei movimenti sindacali, e che avrebbe un potere di trasformazione potenzialmente molto grande: crea popolazioni estremamente mature sul piano politico, da alle persone che abitano sui territori dello Stato la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso, traducendo in realtà prospettive altrimenti puramente astratte (e una prospettiva astratta non mobilita gli affetti allo stesso modo).
Al contrario di quanto accusa una parte della sinistra più tradizionale, secondo cui si finirebbe semplicemente col farsi l’orto da qualche parte abbandonando il proletariato alla sua condizione, pensiamo invece che questi territori hanno delle virtù intrinseche e sono anche delle possibilità flessibili.

Com’è possibile che questi territori si mantengano considerato che gli Stati dispongono di una forza coercitiva enorme?
Questo pone chiaramente un problema, ma immaginiamo una serie di situazioni in cui una coabitazione forzata fosse possibile. Per esempio, in una situazione di seria instabilità politica – come un movimento dei gilet gialli moltiplicato per dieci – lo Stato non avrebbe che una sola risposta, fortemente repressiva, e le classi dominanti avrebbero un mero comportamento di autodifesa, mentre tutte le strutture che avranno sviluppato con successo forme di solidarietà, di mutuo soccorso e di autonomia si troverebbero a sopperire a bisogni primari della popolazione, mantenendo condizioni di vita decenti, e da un tale periodo di instabilità si potrebbe uscire trovandosi in una situazione politica simile, al netto di alcune ovvie differenze, a quella conosciuta alla fine della Seconda guerra mondiale. Per esempio, se lo stato sociale si è affermato attraverso il voto è anche grazie al fatto che il Partito comunista usciva dalla guerra come resistente vittorioso, mentre i grandi industriali, seppure con qualche eccezione, si erano mostrati collaborazionisti. In una situazione simile tutte le forme di autonomia territoriale, di solidarietà locale, di movimento associativo, uscirebbero dalla crisi con tutte le virtù del caso, mentre lo Stato e i padroni sarebbero del tutto screditati e si troverebbero obbligati a riconoscere le strutture istituzionalizzate dei territori autonomi e soprattutto la loro creazione, estensione, organizzazione in reti. Ci sono poi altri scenari possibili, ma quella di costringere, in un modo o nell’altro, lo Stato, di questi tempi è in realtà una delle principali prospettive politiche che non è irragionevole avere.
In effetti, mi sembra che si parli molto della possibilità di collettivi autonomi in campagna.
Riunire e federare forme di solidarietà e mutualismo tra movimenti rurali, contadini e movimenti di occupazione urbana è una grossa sfida, ma esistono diversi modi. Il collettivo «Reprise de terre» si pone direttamente queste domande: gli orti urbani, la ripresa delle terre in città per permettere forme di sussistenza minima, sono cose che si sviluppano in parecchi posti. Nelle grandi città dell’America del Sud è così che la popolazione è sopravvissuta nel periodo delle restrizioni pandemiche… Potrebbe suonare come un semplice aneddoto ma non lo è: l’antropologia e la storia mostrano che in generale le popolazioni umane hanno sempre oscillato su base stagionale tra modi di vivere estremamente diversi, sia in termini di sussistenza che di organizzazione politica. Da qui possiamo immaginare movimenti di popolazione stagionali tra centri più urbanizzati e territori di produzione agricola in cui ciascuno in un modo o nell’altro potrebbe partecipare alle attività per una parte dell’anno. Nel prossimo futuro, sono sicuramente interazioni di questo tipo che bisogna immaginare e costruire.
Alla fine del libro, difendete l’eterogeneità dei modi di stare al mondo, ovvero non difendete un modello che dovrebbe applicarsi ovunque.
Riteniamo che un mondo vario e diverso sia più bello da vivere che un mondo noioso e uniforme. Un mondo in cui ci sia una sola regola del gioco, un solo modo di essere una persona valida, è un mondo completamente deprimente. Una proliferazione di territori con diversi modi di organizzazione politica, diverse maniere di sostentarsi e soddisfare i bisogni, diversi sistemi di valori, crea possibilità di emancipazione molto maggiori di un mondo uniforme in cui le condizioni di dominazione sono ovviamente più severe e violente che in un mondo in cui esistano molteplici possibilità di scelta.
In generale insistiamo sul principio della diversità anche perché ci sembra un valore meno antropocentrico e etnocentrico di molti altri. Si può ritenere, senza correre troppo il rischio di proiettare e antropomorfizzare, che la diversità è anche nell’interesse degli ecosistemi, degli ambienti di vita. Ci sembra insomma un valore con un buon numero di virtù e possiamo forse considerare la diversità come l’unico valore veramente universale, da prendere come presupposto per pensare tutto il resto.


 Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi.
Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi. Mancanza di sintesi. Come scriveva
Mancanza di sintesi. Come scriveva  Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.
Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.