
La settimana scorsa, Lundi Matin ha pubblicato l’appello di una dottoranda per la politicizzazione delle cosiddette “scienze dure”. Si tende, per lo meno in Francia, a ritenere che le questioni politiche e sociali interessino poco chi si occupa delle cosiddette “scienze dure”, in quanto tali questioni ricadrebbero in una qualche maniera al di fuori del loro campo e sarebbero riservate piuttosto ai ricercatori in scienze sociali. Eppure, in questi ultimi anni, l’importanza assunta dalle questioni climatiche, ambientali ed ecologiche sta scombinando le carte e spinge sempre più scienziati e scienziate a partecipare al dibattito pubblico ed schierarsi politicamente. Proprio a ciò incoraggia questo testo.
Il testo affronta una serie di questioni che in Italia sono già state discusse in maniera più o meno ampia a livello della teoria politica, ma forse non abbastanza metabolizzate sul piano della pratica e dell’impostazione discorsiva. L’ultima prova lampante è la quasi totale inconsistenza dei movimenti rispetto alle misure adottate in Italia in nome della pandemia, ma si potrebbero fare altri esempi in relazione alla fiducia cieca e al rispetto incondizionato che la generica sinistra “istruita” ripone nelle istituzioni scientifiche o nel Burioni di turno, a prescindere da ogni analisi che tenga conto dei rapporti di forza e dei conflitti che operano nella società, spesso a costo di reagire con una saccenza classista ed elitaria. Questo atteggiamento si chiama “scientismo” ed è esattamente quanto intende denunciare il testo che mi è sembrato opportuno tradurre. Visto che sono questioni già discusse in Italia, una parte di lettori e lettrici vi troverà asserite delle ovvietà, ma ripeterle di questi tempi non fa certo male, specie se si sottolinea la necessità di agire sul piano delle pratiche politiche e non fermarsi alla sola riflessione teorica.
In materia di ecologia, il discorso scientifico occupa oggi una posizione considerevole, in particolare per quanto riguarda le scienze della natura (espressione qui usata per riferirsi a scienze come la meteorologia, l’oceanografia, la climatologia, la glaciologia, la biologia, l’ecologia scientifica, l’ornitologia, ovvero scienze il cui oggetto di ricerca rende conto, direttamente o indirettamente, delle devastazioni ecologiche attuali come il riscaldamento globale o l’erosione della biodiversità; si noti che si tratta di scienze la cui parola gode di una legittimazione forte da parte della stampa e che gli e le scienziate della natura sono relativamente poco politicizzati). Ogni nuovo rapporto dell’IPCC (gruppo inter-governativo sul cambiamento climatico, foro scientifico dell’ONU nato per studiare il riscaldamento globale) o del simile IPBES (piattaforma inter-governativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici) è riportato e commentato dalla stampa. Le analisi scientifiche del cambiamento climatico e dell’erosione della biodiversità compaiono tanto sui cartelli alle manifestazioni quanto nei discorsi del ceto politico (si noti che in Francia, contrariamente al altri paesi, esiste un consenso abbastanza solido a tale riguardo e il “negazionismo climatico” resta molto minoritario). Gli e le scienziate della natura ne sono pienamente coscienti e considerano che il loro staturo conferisca loro un preciso dovere di divulgazione delle proprie conoscenze. Per varie ragioni, c’è tra loro chi raccomanda o si vede imporre la “neutralità”, sia in termini di discorso che di posizione. Sebbene tale tentativo possa apparire legittimo, esso si basa su ignoranze e fraintendimenti che confondono il metodo scientifico con la neutralità, l’ecologia in senso scientifico con l’ecologia in senso politico.
Discorso neutro o discorso vuoto?
Quando si tratta di descrivere gli oceani, le nuvole, le specie animali e vegetali, le foreste, i suoli, o quando si tratta di rendere conto delle attuali devastazioni ambientali, il solo modo di essere neutri sarebbe tacere, il che ovviamente non sarebbe affatto soddisfacente in termini di comunicazione scientifica.
Infatti, la scelta delle parole riflette i valori, la cultura e la visione del mondo di chi parla. Se esiste una battaglia di idee in merito alle parole impiegate per descrivere le distruzioni ecologiche, è perché esse sono di fondamentale importanza politica. Il termine “antropocene” è un caso eclatante: benché usato spesso dai media e da scienziati e scienziate della natura, è stato fortemente criticato e diverse alternative sono state proposte per sopperire ai suoi limiti. Il problema è che identificando un’ipotetica umanità indivisibile come agente delle devastazioni ecologiche attuali, il termine reso popolare alla fine del XX° secolo dal meteorologo e chimico Paul Josef Crutzen non permette di cogliere la ripartizione ineguale delle responsabilità all’interno della specie umana. Per esempio, si considerano insieme le società industriali e i popoli cosiddetti autoctoni o indigeni (la versione originale parla anche di popoli “primitivi” o “selvaggi”, ma mi rifiuto di utilizzare questi vocaboli, NdT), eppure questi ultimi non hanno niente a che vedere con ciò che chiamiamo, per questo a torto, “antropocene”. Anzi, alcune delle società non industriali sembrano addirittura fornire la prova vivente del fatto che la specie umana può vivere in equilibrio con il suo ambiente e rappresentano una fonte di ispirazione per immaginare le profonde trasformazioni a cui le devastazioni ecologiche dovrebbero spingere le nostre società. Per questo, c’è chi preferisce parlare di “industrialocene” o ancora di “occidentalocene”. Oppure chi identifica nel capitalismo il principale responsabile del disastro, e parla allora di “capitalocene”. Quest’ultimo concetto ha il merito di puntare il dito sul fatto che anche all’interno delle società industriali la responsabilità non è ugualmente condivisa tra gli individui (per esempio, il 7% più ricco produce il 50% di emissioni di diossido di carbonio, il 45% più povero solo il 7% delle emissioni): sono coloro che amministrano il capitalismo e supportano l’ideologia corrispondente ad esser chiamati in causa.
È dunque chiaro che la scelta del termine “antropocene” per designare l’epoca geologica attuale, sebbene sia comune in certi ambienti scientifici e giornalistici, non ha nulla di neutro e, come molti termini derivanti dal campo delle scienze della natura, ha acquisito un portato fortemente politico. Il suo utilizzo rinforza certi preconcetti che ci impediscono di immaginare un mondo desiderabile per il “dopo” e alimenta una visione misantropica secondo cui gli umani in generale sarebbero il virus che devasta il pianeta. Se è certo che l’uso della parola “capitalocene” costerebbe a una scienziata la qualifica, da parte della stampa e dei colleghi, di essere schierata, se non proprio accusata di non-neutralità, lo stesso non può dirsi del termine “antropocene”. Voler descrivere il mondo in una maniera che si presume neutra porta in fondo a plasmare il proprio discorso sull’ideologia dominante, favorendo quindi lo status quo.
Neutralità e status quo
Consideriamo il caso di una presentazione su delle proiezioni climatiche della temperatura della superficie terrestre, in cui la persona che presenta sia portata a mettere le proprie ricerche in prospettiva e fornire un contesto che inquadri e giustifichi il proprio lavoro. Si parlerà per esempio di “transizione ecologica” o ancora di “obiettivi di sviluppo sostenibile”. In generale, si darà per scontata la necessità delle attività industriali, la disponibilità delle tecnologie attuali, un livello elevato di consumo di energia e materiali (questo è l’approccio tenuto, per esempio, dall’IPCC e l’IPBES). Benché la sobrietà e il risparmio siano sempre raccomandati, non si precisa mai dove si colloca il limite tra la sobrietà e lo spreco. L’istituzione statale sarà presa come norma e considerata come forma democratica di gestione. Si condanneranno i danni all’ambiente unicamente nella misura in cui avranno effetti sull’umanità: per esempio, la scomparsa di specie vegetali a causa del cambiamento climatico sarà messa in evidenza per le eventuali proprietà medicinali di questa o quella pianta, non per il loro valore intrinseco. Nel proporre eventuali soluzioni si dimenticherà, come spesso accade, l’impatto che l’estrazione mineraria necessaria alla transizione energetica occidentale ha sulle popolazioni locali in Asia, in Africa o America Latina. Una visione contabile, antropocentrica, etnocentrica e sociocentrica del mondo animerà i propositi scientifici della persona che interviene. La stessa cosa potrebbe verificarsi per una presentazione sull’acidificazione degli oceani, lo scioglimento dei ghiacci o la circolazione atmosferica. Una tale posizione non sarà considerata “di parte”, eppure lo è.
Scienziati e scienziate della natura che fanno propria tale visione del mondo potranno esprimerla senza arrossire, a volte senza neppure rendersi conto che le proprie affermazioni non sono ovvie e scontate. Chi invece nelle scienze della natura pensa che è necessario cambiare radicalmente prospettiva, rimettere in causa i valori e i modelli sociali attuali, non oserà difendere le proprie idee per timore della disapprovazione dei colleghi, o addirittura di vedere messa in dubbio la propria integrità scientifica. Eppure, la documentazione scientifica delle devastazioni ambientali dovrebbe proprio portarci ad uscire dallo status quo, a sovvertire il nostro immaginario per trovare soluzioni in cui la specie umana, le altre specie animali e il loro ambiente di vita siano preservati.
L’illusione della posizione neutra
È impossibile avere una posizione neutra in un contesto politico. Quest’ultimo è fatto di opposizioni, di rapporti di forza, di conflitti, di vittorie per alcuni e sconfitte per altri. Evitare di prendere posizione significa agire in favore dello status quo, avallare le oppressioni invece che combatterle. Tra l’altro, come fa notare Jean-Baptiste Fressoz, storico delle scienze e dell’ambiente, la questione della “militanza politica” delle persone di scienza viene sempre posta quando esse mettono in questione l’ordine sociale, mai quando lo sostengono. Credere nella possibilità di una posizione neutra ricade in una concezione idealizzata del dibattito politico, che si vorrebbe mero scambio di idee da cui risulterebbe una decisione comune organizzata democraticamente dalle istituzioni politiche. Non è affatto così. Le attuali forme di governo sono autoritarie, dalle aristocrazie elettive che sono gli Stati alle grandi imprese gerarchiche sottoposte esse stesse al mercato. In tale contesto, non prendere posizione significa lasciare il potere decisionale ai “responsabili” politici e alla “razionalità” economica che hanno portato proprio alla situazione attuale mettendo in pericolo le condizioni di vita e devastando il mondo vivente sulla Terra.
La figura dell’esperto è il problema
La ricerca di neutralità da parte delle persone di scienza deriva dalla posizione di “esperte” che è loro attribuita nella società e nel dibattito pubblico. I sistemi di governo autoritari che conosciamo sono fondati sul primato del sapere tecnico su ogni altra forma di sapere. Lo scientismo (che altrove è stato definito una “nuova chiesa universale”) ritiene che solo il metodo scientifico permetta di accedere alla verità e che quindi ogni decisione deve essere presa sulla base di fatti stabiliti scientificamente. Questo postulato conferisce alla figura dell’esperto uno statuto di autorità. Come persona di scienza è allora legittimo non voler prendere una posizione in nome della scienza in un dibattito di idee politiche, per non scalfire lo statuto di autorità per la difesa di posizioni personali. Questo proposito è in effetti ingannevole, perché la conoscenza scientifica non permette mai da sola di affermare se questa o quella posizione politica sono buone. D’altro canto, un tale abuso rischierebbe di mettere in crisi la credibilità della parola scientifica. Eppure, una persona di scienza non deve privarsi di esprimere la propria posizione come individuo, perché non si può non prendere posizione, come visto già sopra.
Del resto, se una persona di scienza quando esprime la propria opinione come individuo deve mostrarlo chiaramente e non farlo in nome della scienza, ciò non deve dar l’impressione che il suo lavoro scientifico sia, in sé, neutro. Sbaglierebbe chi dicesse che chi fa scienza deve comunicare in modo esplicito separando i momenti in cui milita in quanto cittadino e quelli in cui si posizione in quanto ricercatore. Da un lato, l’individuo e il ricercatore sono indissociabili, dall’altro metodo scientifico non significa neutralità ma piuttosto attendibilità (essendo i risultati verificabili e riproducibili). Questi fatti sono da esplicitare fin dall’inizio quando una persona di scienza interviene in un dibattito pubblico.
Inoltre, lo scientismo inibisce in chi fa scienza della natura la capacità di esprimersi su questioni di società diverse dall’oggetto diretto dei propri lavori di ricerca. Di fatto, se solo gli esperti hanno ragione, allora la parola di un non esperto non è mai legittima, così come un oceanografo non dovrebbe esprimersi in questioni di agricoltura, un biologo non dovrebbe esprimersi in questioni di produzione energetica e così via.
Tuttavia, questo funzionamento tecnocratico ha dato prova di non essere capace di risolvere i problemi che produce, in particolare in materia di difesa della natura. La specializzazione a oltranza delle competenze tecniche impedisce agli individui di comprendere il mondo nella sua globalità e la delega delle decisioni a un’aristocrazia (sia pur eletta) porta all’accaparramento della natura da parte di una minoranza. Peraltro, nonostante la serie di nuove soluzioni tecniche ai problemi ambientali provocati dalle attività industriali, i danni non accennano a ridursi.
Infine, va tenuto ben presente che la prospettiva di un potere autoritario “ecologico” in cui la gestione delle risorse naturali fosse assicurata da un estremo controllo della popolazione non è affatto felice. Lo spettro dell’ecofascismo è presente, incombe fin dal Rapporto sui Limiti dello Sviluppo e si avvicina sempre più con il fiorire delle “smart cities” (si suppone che le città intelligenti dovrebbero migliorare la gestione e la distribuzione delle risorse, ma sono un ottimo pretesto per il dispiegamento di politiche securitarie, di sorveglianza e controllo della popolazione, che spesso il capitalismo si affretta a dotare di un’aura verde ecosostenibile). Esistono svariate società possibili che prendano in considerazione i limiti del pianeta e non saranno gli esperti a poter decidere quale progetto politico ecologico sia “migliore”. Esiste una grande differenza tra ambientalismo ed ecologia politica: quest’ultima permette di comprendere che non esistono traiettorie univoche dettate da considerazioni ecologiche.
La scelta del pubblico
I rapporti scientifici dell’IPCC o dell’IPBES non vengono dal nulla: conformemente all’organizzazione tecnocratica delle nostre società, essi sono inizialmente destinati ai responsabili politici (così come da loro sono commissionati), per consentire loro di prendere quelle che si presumono le migliori decisioni. Questi rapporti hanno tuttavia assunto un peso considerevole nel dibattito pubblico: permettono ai non esperti, cioè cittadini e cittadine, di informarsi sulle devastazioni ecologiche, di comprendere meglio il funzionamento del mondo naturale in cui viviamo e sono anche un mezzo di fare pressione su chi governa. In questo modo le persone di scienza, attraverso uno strumento tecnocratico come i rapporti scientifici destinati a chi decide, alimentano paradossalmente una trasmissione di sapere e di potere verso il basso.
Nelle scienze della natura, molte persone sono tuttavia persuase che i rapporti scientifici non siano abbastanza e che sia necessario andare incontro al pubblico per trasmettere le proprie conoscenze: si impegnano così nella divulgazione e nella comunicazione, e ciò non può che essere accolto positivamente. La scelta del pubblico cui si rivolgono ha anch’essa carattere politico. Il fatto che Jean Jouzel, ex-vicepresidente dell’IPCC nonché ex direttore dell’Institut Pierre Simon Laplace, tenga delle conferenze sul clima a bordo di navi da crociera di lusso è stato fortemente criticato da parte del movimento ecologista. Non si può considerare neutro neanche il fatto che Hervé Le Treut, neodirettore dello stesso istituto, abbia tenuto una conferenza a un meeting del partito di Macron, En Marche. In Francia, Valérie Masson-Delmotte è probabilmente la ricercatrice più attiva nella diffusione dell’informazione scientifica sul clima. Oltre a intervenire nelle università e nella stampa, sceglie di andare a incontrare chi milita nel movimento per il clima e anche di discutere con Assa Traoré (che lotta tenacemente per reclamare verità e giustizia dopo l’assassinio di suo fratello Adama Traoré da parte della polizia francese nel 2016). Tale iniziativa è di particolare importanza visto che la popolazione che si considera “ecologista” è in maggioranza bianca e proveniente da classi sociali agiate. Si vede dunque dalla diversità di pratiche che la scelta del pubblico a cui ci si rivolge non è mai neutra, proprio come la natura del discorso e la posizione assunta da chi parla in quanto persona di scienza.
Chi fa scienza è un soggetto politico
Se il metodo scientifico permette di controllare oggettivamente la veridicità di un’affermazione, l’oggetto di studio è comunque sempre definito da valori e priorità che sono, esse, politiche. Le istituzioni, le modalità di finanziamento e di funzionamento della scienza non sono né oggettive né razionali. È indispensabile che coloro che fanno scienza si approprino, se non lo hano ancora fatto, della dimensione politica delle proprie discipline. In realtà, molte persone sono impegnate in un impostazione di riflessione politica profonda, e attingono alle scienze umane e sociali informazioni preziose: cominciano a prendere posizione nelle tribune o in occasione delle presentazioni scientifiche, si impegnano in azioni sindacali, partecipano attivamente ai movimenti, creano collettivi di ecologia politica. Questo testo è un appello per l’amplificazione di questo movimento di politicizzazione delle scienze della natura.
Verso la politicizzazione
Per trasformarsi da scienze ridotte ad analisi tecniche in scienze capaci di assumere e cogliere la propria funzione politica, è necessario aprire i mondi della ricerca. Le scienze della natura non avrebbero che da guadagnare mescolandosi a discipline come l’antropologia, l’economia, la filosofia, la sociologia o la storia, essenziali per comprendere ciò che porta alle devastazioni ecologiche. Dei collettivi di ricerca, come l’Atécopol di Tolosa, si muovono già in quest’ottica di scambio tra le discipline. Questa impostazione permette di capire il mondo nella sua globalità per assumere una posizione politica piuttosto che allinearsi automaticamente a uno status quo potenzialmente devastatore. Una simile apertura e presa di posizione implicano di uscire dal ruolo di esperti ed esperte e di condannare la tecnocrazia, come alcuni collettivi quali Survivre et Vivre fecero già negli anni 1970. Il prolungamento naturale di questo percorso è l’apertura all’insieme dei non esperti che lottano per una nuova società in cui l’ecologia sia centrale e non si riduca a qualche aggiustamento marginale di pratiche invariabilmente distruttive.

 Il secondo motivo è che il consenso per Grillo deriva in larga parte da impulsi irrazionali, catalizzati dallo stile comunicativo, dal tipo di linguaggio e dalla teatralità del personaggio, come sapientemente indagato da Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all’Università di Bologna (l’analisi è suddivisa in
Il secondo motivo è che il consenso per Grillo deriva in larga parte da impulsi irrazionali, catalizzati dallo stile comunicativo, dal tipo di linguaggio e dalla teatralità del personaggio, come sapientemente indagato da Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all’Università di Bologna (l’analisi è suddivisa in 
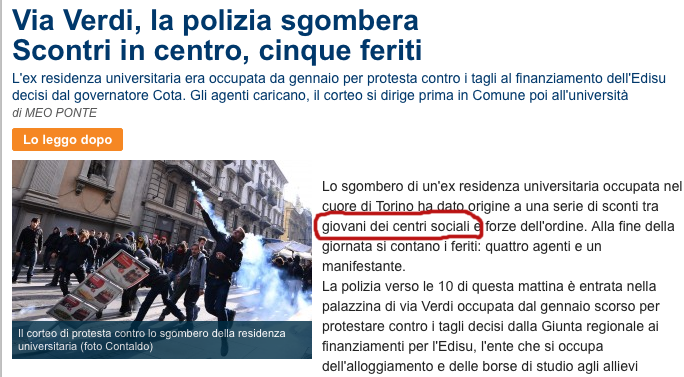
 La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”.
La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”.
 Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo
Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo