Nel post precedente ho parlato dell’aspetto straniante di Facebook e dei meccanismi, interni o esterni ad esso, che lo rendono un così fortunato social network: la forza totalizzante, la dipendenza dalle notifiche, lo stigma sociale per chi non c’è dentro. Queste sono le principali caratteristiche per cui è facile entrarci ed è difficile uscirne, come in un giro di droga. Nella seconda parte della mia analisi tratto invece di un altro aspetto di Facebook, cioè i processi di controllo che esso mette in atto.
![]() Che Facebook sia un ottimo strumento di controllo non stupisce: una rete in cui centinaia di milioni di persone mettono a disposizione dei suoi server dati personali è oggettivamente una fonte inesauribile di informazioni. Basti pensare all’esistenza di software in grado di compiere il riconoscimento facciale di una qualsiasi fotografia confrontandola con un numero consistente di altre fotografie: in pratica se si avesse una collezione di foto di tutti, si potrebbe riconoscere chiunque solo utilizzando questi programmi. Bene, questa collezione è Facebook, da cui si possono conoscere molti dati che gli utenti non scrivono direttamente sul sito: in questo esempio, con un confronto incrociato, dei ricercatori hanno scoperto quali utenti erano iscritti anche a un sito di appuntamenti senza che questi lo avessero mai dichiarato su Facebook. Le possibilità di utilizzo possono naturalmente essere tante altre.
Che Facebook sia un ottimo strumento di controllo non stupisce: una rete in cui centinaia di milioni di persone mettono a disposizione dei suoi server dati personali è oggettivamente una fonte inesauribile di informazioni. Basti pensare all’esistenza di software in grado di compiere il riconoscimento facciale di una qualsiasi fotografia confrontandola con un numero consistente di altre fotografie: in pratica se si avesse una collezione di foto di tutti, si potrebbe riconoscere chiunque solo utilizzando questi programmi. Bene, questa collezione è Facebook, da cui si possono conoscere molti dati che gli utenti non scrivono direttamente sul sito: in questo esempio, con un confronto incrociato, dei ricercatori hanno scoperto quali utenti erano iscritti anche a un sito di appuntamenti senza che questi lo avessero mai dichiarato su Facebook. Le possibilità di utilizzo possono naturalmente essere tante altre.
Quando ci si iscrive a Facebook si accettano delle condizioni sulla privacy che recitano: «Facebook può inoltre condividere le informazioni se ha ragione di ritenere che sia necessario per: individuare, prevenire e segnalare frodi e altre azioni illegali». Ma Facebook non è un magistrato, non può arrogarsi il diritto di ritenere che delle illegalità siano in via di attuazione. E anche se fosse un magistrato, si sa bene quanto poco ci si dovrebbe fidare di “azioni preventive”, come la “guerra preventiva” imperialista in Iraq o come i “fermi preventivi” fascisti della polizia italiana prima di grandi manifestazioni.
La condivisione di notizie con le forze di sicurezza di molti paesi, anche senza prove di reato ma solo sospetti, è stato ultimamente uno scopo parecchio ambito, e a volte ottenuto, non solo dai regimi dittatoriali intimoriti dall’ondata rivoluzionaria del Nord Africa, ma anche dai governi occidentali come quello inglese di Cameron, durante le rivolte urbane dello scorso agosto.
Ora, come ogni altro strumento, Facebook può essere utilizzato con diverse finalità: in effetti non è con i social network che si apre una nuova era di spionaggio politico mondiale finalizzato al controllo delle masse. Prima c’erano altri strumenti come il controllo delle linee telefoniche, i pedinamenti, insomma lo spionaggio vero e proprio, in carne ed ossa. Quindi, come detto prima, non è questo l’aspetto di Facebook che deve stupire.
Invece, il dato importante è che Facebook sia riuscito a monetizzare i rapporti interpersonali con un’efficienza che fa impallidire qualsiasi sistema di sfruttamento capitalistico: il controllo esercitato da Facebook, prima che per la “sicurezza”, che per un’azienda di questo tipo è un pretesto per continuare ad esistere facendosi bella con i governi e le polizie, passa per processi finalizzati al guadagno.
 Nella prima parte di queste considerazioni, è stato detto che è un sollievo scoprire di non essere dipendente da Facebook; tuttavia, le cose cambiano se contestualmente si scopre di essere dipendente di Facebook. Ogni utente, attraverso i link condivisi, le parole utilizzate, gli amici e le pagine frequentate, mette automaticamente a disposizione dell’azienda delle informazioni aggiuntive che rendono possibile l’individuazione di un target nel sistema di pubblicità personalizzato; in altre parole, a seconda di ciò che scrivi su Facebook, dei “mi piace” che metti e dei link che condividi, oltre che naturalmente ai tuoi dati del profilo, ti vengono proposte pubblicità di prodotti diversi, vicini il più possibile alle tue preferenze: «più sei popolare, più visite ricevi, più “amici” hai, più sei “accountabile” e allettante per la pubblicità» (parole di lucapadovano qui). Questa strategia pubblicitaria non è nuova, ma con Facebook raggiunge livelli di personalizzazione di una minuziosità mai sfiorata prima: la società consumistica di massa diventa società consumistica dell’individuo.
Nella prima parte di queste considerazioni, è stato detto che è un sollievo scoprire di non essere dipendente da Facebook; tuttavia, le cose cambiano se contestualmente si scopre di essere dipendente di Facebook. Ogni utente, attraverso i link condivisi, le parole utilizzate, gli amici e le pagine frequentate, mette automaticamente a disposizione dell’azienda delle informazioni aggiuntive che rendono possibile l’individuazione di un target nel sistema di pubblicità personalizzato; in altre parole, a seconda di ciò che scrivi su Facebook, dei “mi piace” che metti e dei link che condividi, oltre che naturalmente ai tuoi dati del profilo, ti vengono proposte pubblicità di prodotti diversi, vicini il più possibile alle tue preferenze: «più sei popolare, più visite ricevi, più “amici” hai, più sei “accountabile” e allettante per la pubblicità» (parole di lucapadovano qui). Questa strategia pubblicitaria non è nuova, ma con Facebook raggiunge livelli di personalizzazione di una minuziosità mai sfiorata prima: la società consumistica di massa diventa società consumistica dell’individuo.
Ecco perché tutti gli utenti sono dipendenti di Facebook: inconsapevolmente, centinaia di milioni di utenti lavorano gratis per l’azienda, lo fanno volontariamente e per diverse ore al giorno, ed è un lavoro che, come si faceva notare su Giap, è tutto pluslavoro. Ultimamente, comunque, si è parlato anche di un sistema di retribuzione per chi guarda gli spot pubblicitari su Facebook (10 cent ciascuno): un meccanismo perverso, non c’è che dire, se si considera poi che la valuta di pagamento non è in dollari ma in crediti facebook. Si sta assistendo alla creazione di un giro economico mostruoso tutto virtuale, che riporta alla mente i guadagni già immensi di Second Life.
 Le strategie pubblicitarie si spingono oltre e dimostrano, ancora una volta, che lo scopo di lucro rimane certamente preponderante nella logica della gestione del social network, anche rispetto alla riservatezza degli utenti: infatti, poco tempo fa è saltato fuori che, a insaputa degli internauti, Facebook segue gli spostamenti sul web anche quando non lo stai usando (e anche se non hai un account, basta essere stati almeno una volta sulla pagina iniziale), in modo da affinare la conoscenza sui tuoi gusti. L’unico modo per sfuggire a questo controllo e violazione di riservatezza, se non si è esperti abbastanza da fare modifiche ai cookies, è utilizzare per Facebook un browser differente da quello utilizzato per tutte le altre operazioni online. Da poco si parla anche di condivisione automatica di contenuti, detta frictionless sharing (“condivisione senza attrito”): ogni visita a un sito potrebbe essere pubblicamente tracciata in automatico, rendendo questo meccanismo palese.
Le strategie pubblicitarie si spingono oltre e dimostrano, ancora una volta, che lo scopo di lucro rimane certamente preponderante nella logica della gestione del social network, anche rispetto alla riservatezza degli utenti: infatti, poco tempo fa è saltato fuori che, a insaputa degli internauti, Facebook segue gli spostamenti sul web anche quando non lo stai usando (e anche se non hai un account, basta essere stati almeno una volta sulla pagina iniziale), in modo da affinare la conoscenza sui tuoi gusti. L’unico modo per sfuggire a questo controllo e violazione di riservatezza, se non si è esperti abbastanza da fare modifiche ai cookies, è utilizzare per Facebook un browser differente da quello utilizzato per tutte le altre operazioni online. Da poco si parla anche di condivisione automatica di contenuti, detta frictionless sharing (“condivisione senza attrito”): ogni visita a un sito potrebbe essere pubblicamente tracciata in automatico, rendendo questo meccanismo palese.
In pratica è come una banca: quando usi crediti, le transazioni avvengono sempre tra te e Facebook, anziché tra te e i terzi da cui stai comprando un prodotto online. Come nel sistema bancario, tutto funziona perché Facebook, che è l’intermediario, è un’entità conosciuta, fidata, su cui si può contare, e questa fiducia deriva esclusivamente da una convenzione e un’abitudine che dà sicurezza all’utente. È su questa fiducia che Facebook costruisce il proprio guadagno, prendendosi una bella percentuale delle vendite dei prodotti di terzi venduti grazie alla sua pubblicità.
Insomma, siamo tutti indignati se siamo trattati come merce da politici e bachieri, ma nessuno ha da ridire se siamo merce nelle mani di Mark Zuckerberg.
[continua…]
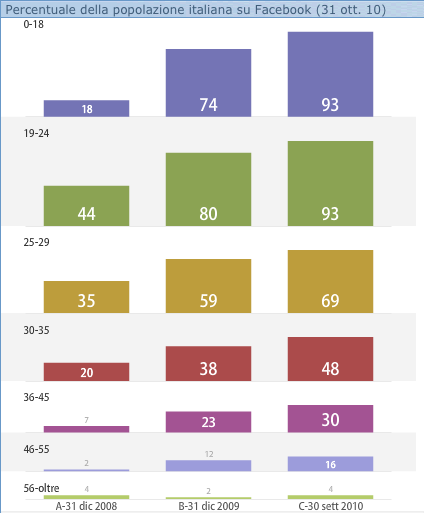
 Lo stile è quello spesso riscontrato in altre opere dello scrittore, con un uso anticonvenzionale della punteggiatura e, in particolare, vorrei ricordare l’espediente letterario che preferisco: i personaggi non hanno mai un nome.
Lo stile è quello spesso riscontrato in altre opere dello scrittore, con un uso anticonvenzionale della punteggiatura e, in particolare, vorrei ricordare l’espediente letterario che preferisco: i personaggi non hanno mai un nome.  Vi rimando, a proposito della vista come senso i cui aspetti possono essere sintomi di qualcosa che nella società non funziona, ad
Vi rimando, a proposito della vista come senso i cui aspetti possono essere sintomi di qualcosa che nella società non funziona, ad  Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi.
Non so se infine sono riuscito nel mio intento di descrivere con oggettività la giornata (scopo che sempre mi riservo, in tutte le situazioni e nella maggior misura in cui è possibile farlo), ma di certo non sono riuscito mio malgrado ad evitare di parlare di tutte le questioni accennate sopra: avrei preferito non farlo, perché parlare della giornata di ieri come una giornata di violenza o di non violenza significa fare il gioco dei potenti e adottare il linguaggio e la retorica dei loro organi di informazione. Ma leggendo tanti commenti sulla rete e diversi articoli di giornali di aree diverse mi sono reso conto che è necessario mettere in chiaro qualche punto: ecco quindi cosa ho scritto. Sono pensieri sparsi. Mancanza di sintesi. Come scriveva
Mancanza di sintesi. Come scriveva  Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.
Opinione personale. Personalmente la violenza degli incappucciati non la condivido, ma non condanno la violenza dei manifestanti che si sono difesi da cariche e da lacrimogeni che li cacciavano da una piazza che doveva essere loro.