Articoli correlati: Il PD è di destra, La fine delle ideologie, Le ideologie sono sempre degli altri
Le precedenti considerazioni sul Partito Democratico mi sono valse accuse di non «fare un’analisi culturale» della questione. In realtà, quando questa critica mi veniva posta, tale analisi era già in fase di stesura. Ve la propongo di seguito (chiedo scusa se è scarna e poco sviluppata, ma la stanchezza di una sessione d’esami ricade anche su queste cose).
Nel contesto di mediaticizzazione e personalizzazione che ha pervaso la politica italiana negli ultimi vent’anni, con la nascita e l’affermazione di partiti prevalentemente subordinati a una personalità importante e onnipresente che funge da marchio e da amplificatore, si deve riconoscere al Partito Democratico il merito di non aver assecondato questa tendenza.
 In realtà, circa dieci anni fa cominciarono a comparire saggi di intellettuali che vedevano una mancanza in questo pregio, e ad essere presi in considerazione i consigli che invitavano la tradizionale sinistra alla ricerca di un leader da contrapporre alle altre forze elettorali più in fase con la tendenza.
In realtà, circa dieci anni fa cominciarono a comparire saggi di intellettuali che vedevano una mancanza in questo pregio, e ad essere presi in considerazione i consigli che invitavano la tradizionale sinistra alla ricerca di un leader da contrapporre alle altre forze elettorali più in fase con la tendenza.
La mancanza di una figura unificante è sintomo dell’altra strada intrapresa dal Partito Democratico di fronte al bivio: quella del pluralismo. Esponenti del defunto PCI banchettavano così insieme ai superstiti della DC; accoglievano fuoriusciti da un gran numero di note sigle della cosiddetta Prima Repubblica, come PSI, PLI, PRI.
Questo trasformismo ha interessato anche per altri partiti, ma con un’altra valenza: in Forza Italia molti migrarono ammaliati dallo scintillio del successo televisivo e della possibilità di tramutare l’immagine in soldi; nelle forze che confluirono nel PD, invece, esisteva ancora un contenuto politico, nel senso che molti si riconoscevano sinceramente nei suoi principî e aderivano in conseguenza ad una scelta ritenuta coerente politicamente. Detto in altre parole: mentre in questa accozzaglia la coesione era data dalla concretezza dei soldi o delle immagini, in quest’altra esisteva ancora un filo conduttore astratto.
Se è vero che non sarebbero mai esistiti partiti come Forza Italia senza Berlusconi o Italia dei Valori senza Di Pietro, solo per citare i due esempi del filone di maggiore successo elettorale (ma non dimenticando il grillismo), è altrettanto vero che il Partito Democratico non sarebbe esistito senza la “fine delle ideologie”. Il pluralismo è la convivenza di idee diverse e la collaborazione tra individui e gruppi differenti: è su questo concetto, a cui spesso ci si riferisce con “democrazia”, che il PD ha costruito, a cominciare dal nome, la sua non-identità.
Mentre gli altri partiti in risposta alla “fine delle ideologie” hann o rinunciato alle identità tradizionali e ne hanno acquistato di nuove sotto forma di leader più o meno carismatici, il PD, essendo il partito della “fine delle ideologie”, all’identità definita ha rinunciato tout court, adottando molte delle identità rimaste orfane, per poi di fatto perderle coscientemente sotto forma di pluralismo (detto in altre parole (qui), ci sono «interessi molteplici presenti nella cloaca piddina»).
o rinunciato alle identità tradizionali e ne hanno acquistato di nuove sotto forma di leader più o meno carismatici, il PD, essendo il partito della “fine delle ideologie”, all’identità definita ha rinunciato tout court, adottando molte delle identità rimaste orfane, per poi di fatto perderle coscientemente sotto forma di pluralismo (detto in altre parole (qui), ci sono «interessi molteplici presenti nella cloaca piddina»).
È stato detto che molti si riconoscono nei principî del PD, ma questo sovente è possibile solo perché tali principî sono sfumati, vaghi e interpretabili, si sono allargati in modo da poter accogliere il maggior numero di consensi, un po’ come nel Movimento Cinque Stelle, anche se con una modalità e un retroscena ben diverso: mentre nel M5S non esistono paletti ideologici ma ci si appella al valore inopinabile della maggioranza, nel PD si accetta ogni proposta o posizione purché sia ritenuta “di buon senso”.
Ci si dimentica, in questo modo, che il “buon senso” non esiste: è una costruzione antropologica, un prodotto sociale, un’imposizione culturale che può essere anche violenta. Non, quindi, un criterio neutrale, ma con un indirizzo ben preciso: consolidare il tipo di sistema economico, sociale e culturale che ha prodotto il concetto stesso di “buon senso”. Se si pretende di applicarlo come base delle proprie scelte, si sta facendo assurgere a principio fondamentale qualcosa che è in realtà di profonda natura ideologica.
La conclusione è che il pluralismo del PD, proposto con l’intenzione velleitaria di superare gli steccati ideologici, si rivela uno strumento ideologico. Qualcuno non voleva che si “morisse democristiani”. Questi ci sono già nati.
 In virtù del millantato progressismo, ha sempre sostenuto la necessità di realizzare la tratta di treni ad alta velocità (TAV) nonostante l’opposizione popolare e l’evidente inutilità dell’opera (o meglio, utilità solo per le tasche delle aziende private coinvolte e della mafia infiltrata). Un’inutilità, tra l’altro, ammessa anche dai liberisti puri (
In virtù del millantato progressismo, ha sempre sostenuto la necessità di realizzare la tratta di treni ad alta velocità (TAV) nonostante l’opposizione popolare e l’evidente inutilità dell’opera (o meglio, utilità solo per le tasche delle aziende private coinvolte e della mafia infiltrata). Un’inutilità, tra l’altro, ammessa anche dai liberisti puri (
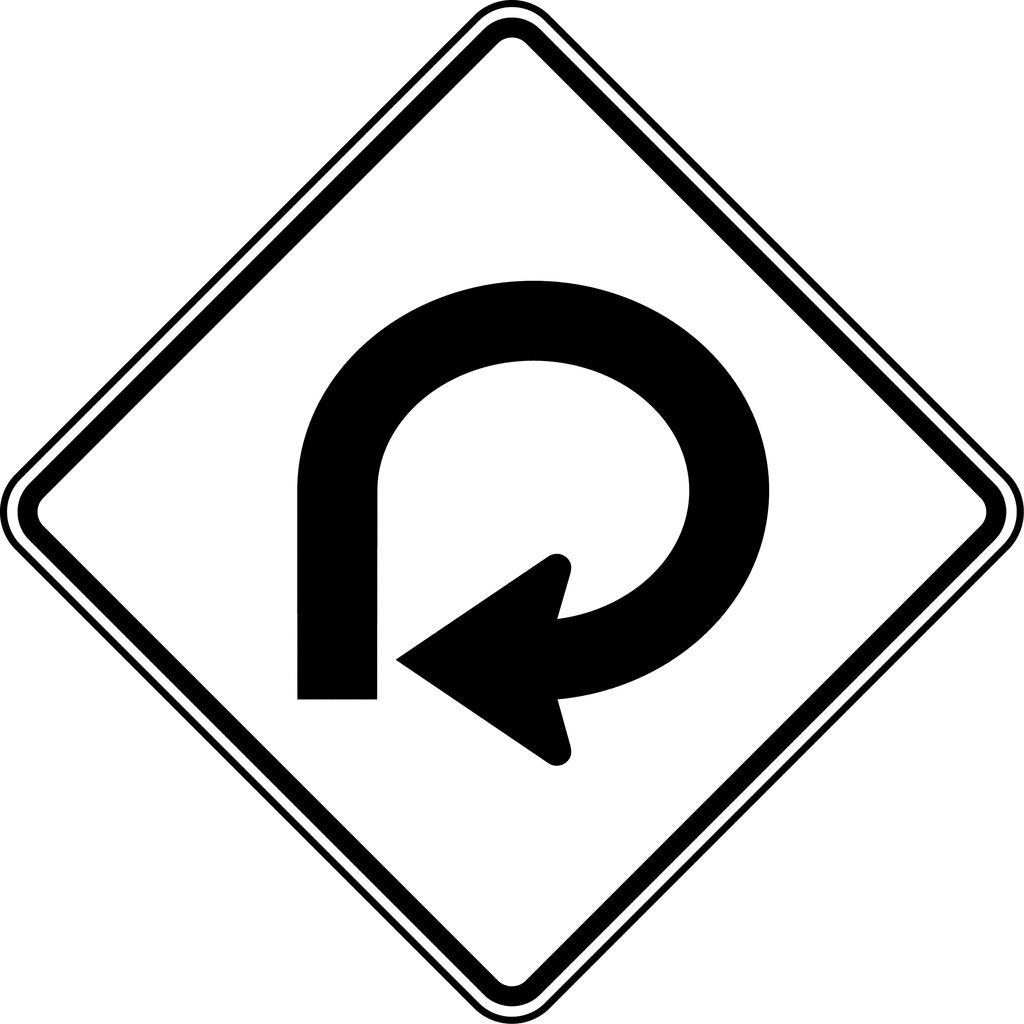
 Il secondo motivo è che il consenso per Grillo deriva in larga parte da impulsi irrazionali, catalizzati dallo stile comunicativo, dal tipo di linguaggio e dalla teatralità del personaggio, come sapientemente indagato da Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all’Università di Bologna (l’analisi è suddivisa in
Il secondo motivo è che il consenso per Grillo deriva in larga parte da impulsi irrazionali, catalizzati dallo stile comunicativo, dal tipo di linguaggio e dalla teatralità del personaggio, come sapientemente indagato da Giovanna Cosenza, professoressa di semiotica all’Università di Bologna (l’analisi è suddivisa in 
 Il secondo modo è espandersi invadendo “nicchie” simili nel panorama dei marchi: per tutelarsi dalla “contraffazione”, Grillo ha registrato anche simboli simili a quello del M5S che potrebbero essere adottati da “cloni” che si dicano forza alternativa, come ad esempio “Pirati a 5 stelle” (
Il secondo modo è espandersi invadendo “nicchie” simili nel panorama dei marchi: per tutelarsi dalla “contraffazione”, Grillo ha registrato anche simboli simili a quello del M5S che potrebbero essere adottati da “cloni” che si dicano forza alternativa, come ad esempio “Pirati a 5 stelle” ( Qualcuno, come Favia, che si proponga come innovatore dall’interno del movimento priva Grillo del suo ruolo: l’innovatore è lui e non deve esserlo nessun altro. In quest’ottica, la cacciata di Favia è dettata più da motivi di natura aziendale che da problemi politici: quello di Favia è un dissenso che si manifesta prima di tutto come rottura dell’incanto maturato attraverso il branding intorno al marchio di Grillo. Infatti l’espulsione, prima che politica è legale: a Favia viene fatto divieto di utilizzare il logo a cinque stelle o di riferirsi al M5S o alla figura di Grillo (
Qualcuno, come Favia, che si proponga come innovatore dall’interno del movimento priva Grillo del suo ruolo: l’innovatore è lui e non deve esserlo nessun altro. In quest’ottica, la cacciata di Favia è dettata più da motivi di natura aziendale che da problemi politici: quello di Favia è un dissenso che si manifesta prima di tutto come rottura dell’incanto maturato attraverso il branding intorno al marchio di Grillo. Infatti l’espulsione, prima che politica è legale: a Favia viene fatto divieto di utilizzare il logo a cinque stelle o di riferirsi al M5S o alla figura di Grillo (