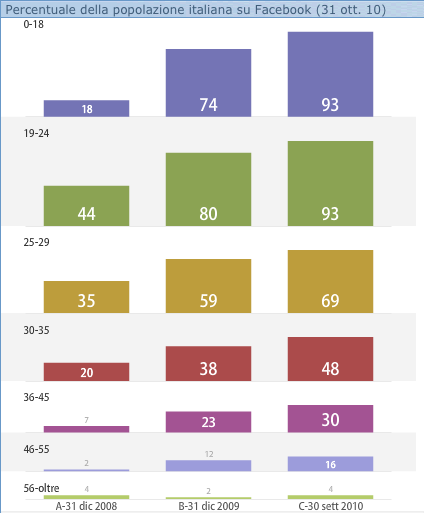Ragusa è una città che non ha mai brillato per impegno politico, inteso nella sua forma partecipativa, che coinvolge e connette partiti, movimenti e associazioni. A parte alcune personalità che si distinsero per l’adesione attiva a campagne di progresso sociale, non ha prodotto, dal punto di vista politico, che mostri informi pronti alla qualunque pur di ottenere il plauso del pubblico ibleo, a patto ovviamente di compiacere il padrone di turno. Quando, nel 1963 e nel 1968, a due successive tornate elettorali, il gerarca fascista Filippo Pennavaria si candidò al Senato, ottenne valanghe di voti dai cittadini ragusani. Non c’è da stupirsi, visto che – fa notare Giuseppe Nativo, studioso di storia iblea – «una certa cultura locale si attarda ancora su pregiudizi, stereotipi e vecchi campanilismi». Campanilismi che, radicati ancor oggi, permettono per esempio il perdurare da anni del dibattito sull’opportunità o meno di piazzare in centro storico una statua in onore del fascista Pennavaria, come se, in un paese civile e democratico, non dovesse essere scontato l’esito di una tale proposta.
È lo stesso campanilismo ad alimentare strani fenomenicome quello che domani (14 gennaio) promette di portare in piazza un cartello trasversale di associazioni che sposta il confronto dal piano locale al piano nazionale e, con provincialismo paraleghista, addita Roma come causa di tutti i problemi dell’economia iblea.
Cominciamo dal principio: in virtù del mio passato di studente “attivo”, ho ricevuto una e-mail dal direttore dell’ANCE Ragusa (“Associazione Nazionale Costruttori Edili”) che desiderava «fornire ragguagli inerenti alla manifestazione di giorno 14 gennaio recante il titolo “Tutti insieme per il rilancio ibleo” promossa dal Tavolo provinciale dello sviluppo e del lavoro di Ragusa che vede riunite tutte le organizzazioni datoriali, sindacali, ordini e collegi professionali, consumatori e le Diocesi di Ragusa e Noto. Il manifesto della manifestazione reca 5 proposte per sostenere le famiglie, difendere il lavoro, sviluppare le imprese e sarà esplicitato al termine dell’evento». Infine, mi si informava che «Oggi 10 gennaio il Presidente della CCIAA di Ragusa si è recato dal Provveditore agli Studi per chiedere l’adesione delle istituzioni scolastiche e consentire una massiccia partecipazione degli Studenti Iblei, futura classa dirigente del nostro Paese».
Molte cose non quadrano da questa prima presentazione: mancano i contenuti e le rivendicazioni della manifestazione, che si riducono ad un generico sviluppo, ad un “rilancio ibleo” e a 5 punti poco esplicitati; si chiede ai cittadini di partecipare all’evento promettendo di esplicitare eventuali contenuti soltanto dopo la manifestazione; si chiede (e si ottiene) l’adesione, a questo punto cieca, degli studenti, addirittura da formalizzare attraverso provvedimenti delle istituzioni scolastiche (non sapevo che una manifestazione di piazza dalle velleità politiche potesse ottenere appoggio istituzionale).
Prima di andare avanti è doveroso precisare quali siano le perplessità, di primo acchito, riguardo i cinque punti programmatici, riportati di seguito: piano straordinario per il lavoro, infrastrutture coerenti e integrate, misure contro l’evasione fiscale e l’abusivismo, semplificazione burocratica, abbattimento dei costi della politica. La perplessità nasce dal fatto che alcuni di questi punti vogliono dire tutto e il contrario di tutto, e questo sincretismo spiega la partecipazione di sigle che vanno dalla CGIL a Confindustria, soggetti sociali che in questo periodo sono in netto contrasto (e sull’art.18, mica bazzecole). È un cartello così trasversale che dentro potresti trovarci di tutto (come nel M5S), o forse solo una cosa.
Bastino un paio di esempi per mettere in guardia. Primo, anche lo smantellamento degli ammortizzatori sociali, l’eliminazione dell’articolo 18, la smania per la “flessibilità” lavorativa e il precariato possono essere considerati , a detta dei tecnici, “piano straordinario per il lavoro”; secondo, anche il Tav e il Ponte sono infrastrutture, bisogna vedere chi ne gestisce la costruzione e con che grado di trasparenza (senza allontanarsi troppo da Ragusa, anche il porto di Marina di Ragusa è un’infrastruttura, ma a che pro? E anche l’ampliamento del porto di Scoglitti lo è, ma fa crollare siti archeologici).
Insomma, chiedere sviluppo non significa nulla, bisogna specificare (perché non è scontato) che tipo di sviluppo, a favore di chi, in che direzione: entrare nel merito.
Si può cercare di risolvere queste perplessità andando a chiedere chiarimenti sulla pagina facebook (già linkata) sollecitamente creata per l’occasione, con tanto di account twitter, canale youtube (con uno spot di vaghissime frasi fatte pronunciate da una voce fascinosa e persuasiva come quelle delle pubblicità): lì gli organizzatori risponderanno che «tutte le parti sociali, nessuna esclusa, tutti gli ordini professionali, le diocesi di Ragusa e Noto, hanno convenuto su 5 proposte concrete» e rimanderanno al primo comunicato, del 17 dicembre, assicurando che vi si possono trovare «molte risposte alle tue domande»; tuttavia si trova lo stesso elenco ambiguo di cui sopra e niente di più.
Perché prima si è parlato di provincialismo paraleghista del tipo “Roma ladrona”? Per capirlo, un altro esempio: quello dell’abusivismo. A detta degli organizzatori è un problema che deve risolvere il governo, perché la colpa è dei governi che, negli anni, a partire dal 1982, hanno condonato a destra e a manca per garantire un certo afflusso nelle casse dello Stato ma, aggiungo io, soprattutto per ottenere voti (e quindi garantire un certo afflusso nelle tasche di singoli eletti). Ma la colpa è solo dei governi o anche di una caratteristica fauna locale che li rappresenta, che anche lei specula e mangia soldi, e che ha ricevuto una valanga di voti dagli elettori ragusani, magari parte dei quali sarà in piazza a protestare? Roma sarà ladrona, ma Roma chi l’ha eletta? Se si fosse voluto veramente combattere l’abusivismo si sarebbe dovuta abbattere sul nascere la cementificazione di una buona metà della costa iblea, anziché lamentarsene ora. Ad aver consentito che questo modello di gestione della costa prendesse piede non è stato il governo nazionale; se i ragusani vogliono trovare responsabili o complici si guardino allo specchio.
Per non parlare di punti sulla semplificazione burocratica e sull’abbattimento dei costi della politica, che vengono coinvolti in una protesta di carattere territoriale quando invece riguarda l’intero paese. Intendiamoci, non che sia sbagliato puntare a questi obiettivi, ma è insensato farlo chiamando in causa l’identità locale: questo sposta inevitabilmente il conflitto (se in questo caso di conflitto si può parlare) dal piano sociopolitico al piano geopolitico, una mossa già abilmente condotta da criptofascisti rossobruni.
Dopo la ripetizione dei soliti cinque punti, sulla pagina facebook è calato il silenzio.
Si saranno forse risentiti per la chiusura dell’intervento? Quella che fa:
Aggiungo una nota a lato sulla partecipazione delle diocesi di Ragusa e Noto: generalmente non sono contrario alla partecipazione a iniziative locali da parte di rappresentanti di Stati esteri, in quanto la cooperazione tra gli stati e le comunità è quanto di più auspicabile si possa volere; tuttavia, non posso che notare una certa faziosità nell’invitare sempre rappresentanti dello stesso Stato estero; la prossima volta raccomando una delegazione del Costa Rica e una del Burundi.
Già, si saranno risentiti. Ma si sa, «una certa cultura locale si attarda ancora su pregiudizi, stereotipi e vecchi campanilismi».
P.S. Non ho inserito il seguente paragrafo nell’articolo perché non ho trovato le fonti dei dati, anche se mi ricordo di averle solo “sentite dire”. Se qualcuno fosse in grado di fornire fonti attendibili gliene sarei grato.
Mi sono chiesto anche come possano i costruttori edili lamentarsi degli affari in provincia, quando solo il capoluogo conta circa 70 mila abitanti ma ha un numero di unità abitative sufficiente per sostenerne 200 mila. Dopo aver investito e mangiato cemento hanno il coraggio di lamentarsi?


 Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo
Da quando, ultimamente, Fiorello ha fatto continui riferimenti al social network dalla diretta tv, il popolino si è iscritto in massa e starnazzante sembra aver invaso l’indigena aggregazione di cinguettii, soffocandola, diluendone i contenuti reali e avviandosi a sostituirla. Se ne sono accorti in molti: secondo 
 Le strategie pubblicitarie si spingono oltre e dimostrano, ancora una volta, che lo scopo di lucro rimane certamente preponderante nella logica della gestione del social network, anche rispetto alla riservatezza degli utenti: infatti, poco tempo fa è
Le strategie pubblicitarie si spingono oltre e dimostrano, ancora una volta, che lo scopo di lucro rimane certamente preponderante nella logica della gestione del social network, anche rispetto alla riservatezza degli utenti: infatti, poco tempo fa è