Le coincidenze a volte sanno essere sorprendenti. Nelle ultime due settimane ho esposto su questo blog le mie perplessità su chi ha la pretesa di considerare universali, naturali, indiscutibili presunti sistemi sociali o leggi economiche quando piuttosto la loro giustificazione è ideologica.
Ho cercato di dimostrare, nei dibattiti sviluppatisi in calce agli ultimi due post, che non esiste un’astratta e settecentesca “natura umana”, perché l’uomo vive in ogni epoca e in ogni luogo immerso in un ambiente culturale e imbrigliato in una rete di rapporti sociali.
E cosa mi capita di andare a seguire? Una conferenza, tenuta da Maria Turchetto, docente di epistemologia delle scienze sociali all’Università di Venezia, peraltro già da me conosciuta come direttrice de L’Ateo, che tratta proprio del tema che mi ha ultimamente affascinato e che continua ad appassionarmi. Ve ne propongo un riassunto, ricostruito dai miei appunti e dalla mia memoria.
Non molti sanno che nella Bibbia sono contenute due versioni della Genesi: in una Dio crea l’uomo a sua immagine e lo crea maschio e femmina, nell’altra, quella più conosciuta, la donna Eva è creata da una costola di Adamo, successivamente alla creazione di quest’ultimo. Nella prima versione i due generi sono creati uguali, mentre nella seconda esiste una evidente subordinazione della donna all’uomo, sia materiale (deriva da una sua parte) che temporale (è creata dopo).
 Richiamandosi all’esegesi biblica, è proprio questo argomento che, nel 2004, l’allora cardinal Ratzinger usò per giungere a una conclusione sulle differenze di genere che si può riassumere con la seguente: è giusto che la donna si adoperi per la conservazione della famiglia tradizionale. La donna ideale è una brava casalinga.
Richiamandosi all’esegesi biblica, è proprio questo argomento che, nel 2004, l’allora cardinal Ratzinger usò per giungere a una conclusione sulle differenze di genere che si può riassumere con la seguente: è giusto che la donna si adoperi per la conservazione della famiglia tradizionale. La donna ideale è una brava casalinga.
Partendo da presupposti differenti, di natura scientifica, negli anni Settanta E. O. Wilson, considerato il fondatore della sociobiologia, giunse alle stesse conclusioni: le donne devono anzi non possono non stare a casa e svolgere un ruolo di cura, perché tale ruolo è determinato geneticamente.
Potrebbe sembrare strano che basandosi su due pensieri così diversi quali quello scientifico e quello religioso si raggiungano idee tanto simili. Eppure questi due ragionamenti hanno qualcosa in comune: il determinismo. Nel caso dell’argomentazione religiosa del cardinal Ratzinger si tratta di un determinismo metafisico («Dio ha detto così quindi non può che essere così»), nell’altro, di derivazione scientifica, di un determinismo meccanicistico («così è scritto inevitabilmente nei geni»); ma sempre di determinismo si tratta, di affermazione dell’esistenza di leggi naturali a cui è impossibile evitare di sottostare.
Le argomentazioni di Wilson suscitarono moltissimo interesse ed ebbero successo, soprattutto presso il pubblico allora crescente di lettori di divulgazione scientifica, ma in verità non si trattava di un fenomeno nuovo: era l’ultimo di innumerevoli esempi storici di utilizzo della biologia come strumento di legittimazione delle disuguaglianze sociali.
Tale utilizzo fu fortemente criticato dal genetista Lewontin, che confutò la teoria sociobiologica fin dalla sua formulazione. In un suo libro, intitolato Biologia come ideologia, egli getta luce sulla fallacia dei presupposti sociobiologici su cui Wilson elaborava le sue teorie: l’errore di Wilson risiede nel considerare un particolare sistema sociale come espressione universale e naturale del genere umano, anziché come costruzione di forze sociali, culturali, politiche.
In questo, nell’epoca moderna è possibile la sostituzione della religione con la scienza come strumento di giustificazione della realtà sociale esistente, affermando attraverso il determinismo l’impossibilità di alternative.
 Storicamente questo è accaduto in epoca moderna con il darwinismo sociale, il razzismo scientifico, la sociobiologia di Wilson. Lorenzo Calabi (in Darwinismo morale) ha definito «circolo fallace» l’artificio dimostrativo che sarebbe sotteso ai ragionamenti basilari di queste teorie, ovvero:
Storicamente questo è accaduto in epoca moderna con il darwinismo sociale, il razzismo scientifico, la sociobiologia di Wilson. Lorenzo Calabi (in Darwinismo morale) ha definito «circolo fallace» l’artificio dimostrativo che sarebbe sotteso ai ragionamenti basilari di queste teorie, ovvero:
Astraggono un comportamento sociale moderno e lo traspongono in una condizione naturale, […] dando ad esso un significato in quella condizione. Astraggono poi il significato e lo ricollocano nella contemporaneità
concludendo così che quel comportamento è naturale e intrascindibile. Questo salto ontologico non è razionalmente accettabile. Allo stesso modo, qualcuno potrebbe osservare le formiche in fila indiana e notare che somigliano a operai lungo una catena di montaggio; tornato poi in fabbrica, troverebbe gli operai al lavoro e, vedendoli in fila indiana, concluderebbe che, dal momento che anche le formiche adottano un comportamento simile, questo deve essere naturale («Toh, gli operai fanno come le formiche, evidentemente è una legge di natura!»).
Il darwinismo sociale è stato formulato da Spencer nella seconda metà dell’Ottocento prendendo spunto dalla teoria darwiniana dell’evoluzione attraverso la selezione naturale: secondo Spencer, ciò che accade in natura, ovvero la lotta per la sopravvivenza e la vittoria del più forte, si replica all’interno della società e ciò avviene inevitabilmente in quanto dovuto a leggi insite nella natura animale dell’uomo. Oltre che per la forzatura e l’interpretazione inesatta della propria teoria (che parla di sopravvivenza del «più adatto» e non del «più forte»), Darwin respinse la paternità di tale trasposizione sociale dell’evoluzionismo non appena gli fu rinfacciato di aver giustificato Napoleone e ogni commerciante che raggiri i clienti, in quanto più forti. Anzi, in opere successive esaltò le qualità collaborative e di solidarietà dell’animale uomo.
Marx, con una strizzata d’occhio al naturalista, riconosceva il circolo fallace nella concorrenza e nell’interpretazione che Spencer ne dava («Nel mercato c’è concorrenza. La competizione è naturale. Dunque il mercato è naturale»).
In effetti, nel caso del socialdarwinismo, il circolo fallace di cui parla Calabi non si chiude: Darwin aveva esplicitamente preso ispirazione, nella formulazione della sua teoria, dall’economista Malthus; ma Malthus non aveva preso ispirazione dalla natura. Si tratta dunque di un semicerchio, in cui la fallacia non risiede tanto in un salto ontologico bensì nell’invasione, da parte del darwinismo, di un ambito esterno al suo campo di applicabilità.
 La sociobiologia di Wilson attribuisce ai geni la responsabilità per comportamenti sociali, procedendo come segue: descrive caratteri comuni dell’essere umano in ogni luogo e in ogni tempo; afferma che tali caratteri sono universali perché genetici; conclude che, essendo genetici, sono stati determinati dal processo della selezione naturale, che seleziona caratteri vantaggiosi per l’individuo e, per estensione, per la specie. Ovvero: viviamo nel migliore dei mondi possibili.
La sociobiologia di Wilson attribuisce ai geni la responsabilità per comportamenti sociali, procedendo come segue: descrive caratteri comuni dell’essere umano in ogni luogo e in ogni tempo; afferma che tali caratteri sono universali perché genetici; conclude che, essendo genetici, sono stati determinati dal processo della selezione naturale, che seleziona caratteri vantaggiosi per l’individuo e, per estensione, per la specie. Ovvero: viviamo nel migliore dei mondi possibili.
I più notevoli tra i caratteri comuni sono, guarda caso: eterosessualità, monogamia, amore per la proprietà privata, predominio del sesso maschile, xenofobia. Si tratta insomma di un pensiero profondamente reazionario espresso in forma scientifica. Oggi un qualunque antropologo può confermare che i caratteri sopracitati non sono effettivamente comuni alle società umane in ogni luogo e in ogni tempo, eppure liquidare la teoria di Wilson come stupida è inutile e potrebbe addirittura rivelarsi dannoso: le masse di “profani”, infatti, notoriamente tendono a optare per la via più lineare, semplice e breve e trascurare questo fenomeno comporta il rischio che si ripetano grandi tragedie come quelle che il secolo XX ha tristemente conosciuto.
Va quindi confutata razionalmente punto per punto. La confutazione sistematica di questo modus operandi prende in esame i passaggi logici in cui si articola e l’affidabilità sperimentale delle presunte affermazioni scientifiche in esso contenute:
–la scelta di caratteri comuni non è scientifica, perché non contempla un controllo; inoltre ignora concetti elementari di antropologia
–affermare che i caratteri comuni sono universali significa confondere la descrizione di un fenomeno con la sua spiegazione
–affermare che i caratteri comuni sono genetici non ha semplicemente senso: sarebbe come dire che siccome in Finlandia sono quasi tutti luterani allora esiste il gene del luteranesimo.
–il meccanismo di espressione genica proposto denota una profonda ignoranza dei principi di biologia dello sviluppo (che del resto erano ancora poco chiari negli anni Settanta)
–ricondurre la presenza di ogni carattere a eventuali vantaggi evolutivi significa seguire erroneamente un ingenuo adattazionismo (mentre non tutto ciò che c’è c’è perché favorito dalla selezione naturale, come spiegato elegantemente qui da Lewontin e Gould). Ragionando così, potremmo dimostrare che le mele cadono verso il basso perché la selezione naturale ha sfavorito quelle che “cadevano verso l’alto”.
Insomma, i tentativi di legittimazione biologica dei sistemi sociali sono di scarso grado di scientificità. Da sempre le classi dominanti hanno cercato di fare apparire le differenze di classe come differenze antropologiche naturali, ma ciò impone loro di rievocare il mondo naturale, in cui, purtroppo per loro, l’enorme varietà di comportamenti e strategie rende del tutto arbitraria la scelta che operano sugli aspetti della realtà: per esempio, in natura la formica regina è la casalinga perfetta, non esce mai di casa e non fa altro che sfornare figli, e sarebbe un ottimo modello per chi volesse sostenere le disuguaglianze di genere, se non fosse che è incestuosa, dato che solo una copula con i propri figli maschi può farle avere figlie di sesso femminile. Ora, nessuno prenderà la formica regina come esempio per dimostrare la naturalità dell’incesto, invece ciò può accadere per il ruolo di cura del sesso femminile o per la catena di montaggio fordista.
 Confutati i principi della sociobiologia, resta da individuare cosa, se non i geni, determina i comportamenti umani nelle loro relazioni sociali. Nel fare questo, si deve reprimere la tendenza a considerare l’umanità, specificità distintiva del genere umano, in contrapposizione all’animalità.
Confutati i principi della sociobiologia, resta da individuare cosa, se non i geni, determina i comportamenti umani nelle loro relazioni sociali. Nel fare questo, si deve reprimere la tendenza a considerare l’umanità, specificità distintiva del genere umano, in contrapposizione all’animalità.
In Ontogeny and phylogeny, S. J. Gould insiste sulla continuità tra uomo e altri animali: sul piano genetico, uomo e scimpanzé sono affini per più del 98%. Allora cosa ci contraddistingue sul piano cognitivo? La risposta deriva paradossalmente proprio dall’alto grado di affinità genetica con i primati più vicini all’uomo: strettissima somiglianza genetica ma importanti differenze nei caratteri rivelano che le differenze genetiche interessano geni regolatori, che influiscono sulla costruzione dell’assetto morfologico, sui tempi dello sviluppo, sull’espressione di altri geni. Da qui deriva l’ipotesi, oggi piuttosto accreditata, che l’evoluzione dell’uomo a partire dalle grandi scimmie primitive sia un caso di neotenia, ovvero di ritenzione di caratteri infantili nello stadio di vita adulto: un uomo appena nato somiglia molto più ad un feto tardivo di scimmia che a una scimmia appena nata e un uomo adulto somiglia molto più ad una scimmia appena nata che a una scimmia adulta. L’uomo ha mascelle non prominenti e denti piccoli, ha pochi peli sul corpo, ha una notevole capacità di apprendimento, è capace di digerire il latte anche da adulto, nelle femmine la vulva è in posizione più frontale che negli altri ominidi, e soprattutto la testa nei neonati è grande in proporzione al resto del corpo e contiene un cervello che alla nascita non è ancora completamente sviluppato.
Da quest’ultima caratteristica dipende il fatto che lo stadio dello sviluppo dell’encefalo che nelle altre scimmie è fetale, nell’uomo avviene in un neonato che è già a contatto con l’ambiente esterno, costituito principalmente dall’esperienza culturale.
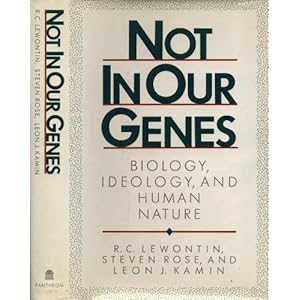 Allora non si può più dire che gli elementi comuni all’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, ammesso che ce ne siano, sono di derivazione genetica, perché potrebbero essere dovuti all’influenza culturale! Che, siccome non è eliminabile, non permette di isolare sperimentalmente i fattori esclusivamente genetici: durante lo sviluppo del cervello, la cultura lo plasma, non solo metaforicamente ma anche materialmente, promuovendo la realizzazione di sinapsi tra certe popolazioni di neuroni piuttosto che tra altre, la sintesi di certi neurotrasmettitori piuttosto che di altri.
Allora non si può più dire che gli elementi comuni all’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, ammesso che ce ne siano, sono di derivazione genetica, perché potrebbero essere dovuti all’influenza culturale! Che, siccome non è eliminabile, non permette di isolare sperimentalmente i fattori esclusivamente genetici: durante lo sviluppo del cervello, la cultura lo plasma, non solo metaforicamente ma anche materialmente, promuovendo la realizzazione di sinapsi tra certe popolazioni di neuroni piuttosto che tra altre, la sintesi di certi neurotrasmettitori piuttosto che di altri.
Qualcuno a questo punto potrebbe pensare di aver dimostrato che l’uomo è del tutto privo di determinazione comportamentale. Non è esattamente così.
Innanzitutto restiamo esseri corporei, costruiti secondo informazioni contenute nei geni, e tale vincolo non è da trascurare, almeno in linea teorica. Per quanto concerne il comportamento, comunque, è l’ambiente a farla da padrone (del resto il comportamento è definito come «modo di agire di un individuo nei rapporti con l’ambiente e con le persone con cui è a contatto») e nel caso dell’uomo l’ambiente è approssimativamente assimilabile alla cultura: non c’è nulla di assoluto.
Detto questo, aggiungo una mia riflessione.
Siamo dunque determinati nei comportamenti non tanto da fattori genetici quanto da fattori culturali. Ora, se fossimo determinati dai geni dovremmo pensare, come i sostenitori del pensiero unico e dei vari tipi di determinismo biologico, che viviamo nel migliore dei mondi possibili, che lo stato di cose presente è inevitabile, che non esistono alternative possibili, perché i geni non sono sotto il controllo della nostra volontà.
Ma siamo determinati dalla cultura, che al contrario dei geni è una nostra costruzione, e che se non ci piace possiamo distruggere, proprio come l’abbiamo costruita, seppur tra mille difficoltà.
Viva Kant, viva la liberazione sociale.



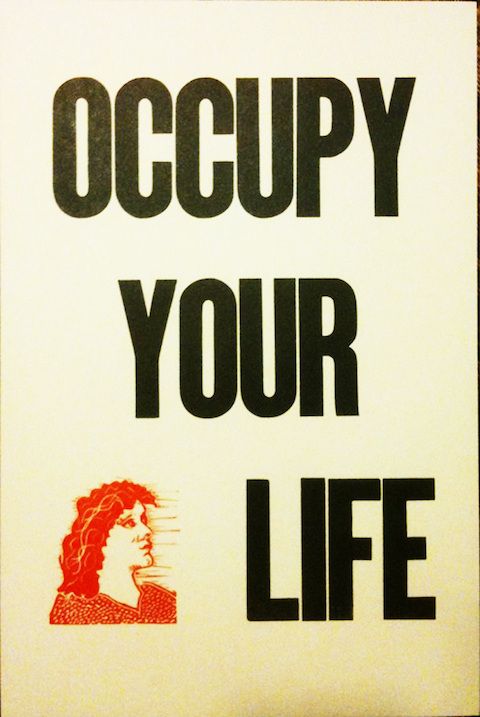 schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla
schemi e i canoni imposti. A partire dalla scelta del prodotto da acquistare, per finire con il modo di camminare, definito dalla  La tecnica ci dice qual è il modo corretto di fare le cose: se non seguiamo i suoi dettami, stiamo tecnicamente sbagliando. Non c’è alternativa tecnica alle soluzioni tecniche dei problemi, quindi addossare a qualcuno la responsabilità di scelte tecniche finalizzate all’attuazione di soluzioni tecniche è non solo scorretto, ma anche stupido. Dal punto di vista di chi sostiene questo paradigma. Se non c’è altra scelta, che colpa ne ha il tecnico?
La tecnica ci dice qual è il modo corretto di fare le cose: se non seguiamo i suoi dettami, stiamo tecnicamente sbagliando. Non c’è alternativa tecnica alle soluzioni tecniche dei problemi, quindi addossare a qualcuno la responsabilità di scelte tecniche finalizzate all’attuazione di soluzioni tecniche è non solo scorretto, ma anche stupido. Dal punto di vista di chi sostiene questo paradigma. Se non c’è altra scelta, che colpa ne ha il tecnico? Come è una scelta puramente tecnica quella di sbarrare la strada,
Come è una scelta puramente tecnica quella di sbarrare la strada,  Uno dei social network di incontri più frequentato è un sito che si chiama OkCupid.
Uno dei social network di incontri più frequentato è un sito che si chiama OkCupid.
 Richiamandosi all’esegesi biblica, è proprio questo argomento che, nel 2004, l’allora cardinal Ratzinger
Richiamandosi all’esegesi biblica, è proprio questo argomento che, nel 2004, l’allora cardinal Ratzinger  La sociobiologia di Wilson attribuisce ai geni la responsabilità per comportamenti sociali, procedendo come segue: descrive caratteri comuni dell’essere umano in ogni luogo e in ogni tempo; afferma che tali caratteri sono universali perché genetici; conclude che, essendo genetici, sono stati determinati dal processo della selezione naturale, che seleziona caratteri vantaggiosi per l’individuo e, per estensione, per la specie. Ovvero: viviamo nel migliore dei mondi possibili.
La sociobiologia di Wilson attribuisce ai geni la responsabilità per comportamenti sociali, procedendo come segue: descrive caratteri comuni dell’essere umano in ogni luogo e in ogni tempo; afferma che tali caratteri sono universali perché genetici; conclude che, essendo genetici, sono stati determinati dal processo della selezione naturale, che seleziona caratteri vantaggiosi per l’individuo e, per estensione, per la specie. Ovvero: viviamo nel migliore dei mondi possibili.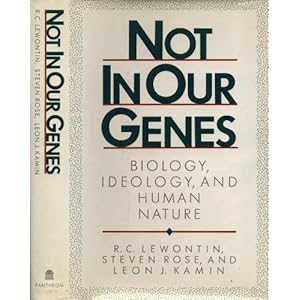 Allora non si può più dire che gli elementi comuni all’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, ammesso che ce ne siano, sono di derivazione genetica, perché potrebbero essere dovuti all’influenza culturale! Che, siccome non è eliminabile, non permette di
Allora non si può più dire che gli elementi comuni all’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, ammesso che ce ne siano, sono di derivazione genetica, perché potrebbero essere dovuti all’influenza culturale! Che, siccome non è eliminabile, non permette di 