Articoli correlati: Sviluppo sostenibile: un ossimoro
 Si può scrivere un libro che parla sostanzialmente di economia, con contenuti fortemente critici nei confronti del capitalismo, senza mai scrivere la parola «capitalismo»?
Si può scrivere un libro che parla sostanzialmente di economia, con contenuti fortemente critici nei confronti del capitalismo, senza mai scrivere la parola «capitalismo»?
Ne avevo il sentore, ma ora che ho letto Come sopravvivere allo sviluppo di Serge Latouche (2005, Bollati Boringhieri) posso confermarlo: è possibile e tale libro ne è un esempio. Il sottotitolo recita: Dalla decolonizzazione dell’immaginario economico alla costruzione di una società alternativa. L’opera si pone quindi tradizionalmente il duplice obiettivo di decostruzione dell’esistente e di costruzione dell’alternativa: la pars destruens deve cominciare da ciò che Latouche definisce una «sovversione cognitiva» (la radicale messa in discussione del concetto di sviluppo), «premessa e condizione di qualsiasi cambiamento politico, sociale, culturale».
La critica del concetto di sviluppo, come è noto per chi sa che Latouche è considerato il più influente sostenitore della teoria della decrescita, si basa sulla limitatzza delle risorse in un mondo finito e la conseguente impossibilità di crescita come dogma su cui imperniare un modello duraturo di società.
L’autore si spinge oltre la critica del semplice sviluppo, e mette in luce la fallacia e l’assurdità dei cosiddetti «sviluppi particolari»: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo sociale, sviluppo locale e così via, tutti in realtà riconducibili, in un modo o nell’altro, a criteri di natura economica e culturale esclusivi del mondo occidentale e industrializzato e dunque non universali, né di conseguenza esportabili senza distruggere ciò che non si adatta ai parametri occidentali.
e l’assurdità dei cosiddetti «sviluppi particolari»: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo sociale, sviluppo locale e così via, tutti in realtà riconducibili, in un modo o nell’altro, a criteri di natura economica e culturale esclusivi del mondo occidentale e industrializzato e dunque non universali, né di conseguenza esportabili senza distruggere ciò che non si adatta ai parametri occidentali.
Si parla della menzogna neoliberista del trickle down effect, che è il nuovo nome dato alla teoria della mano invisibile, secondo cui favorendo gli interessi dei ricchi si favoriscono gli interessi di tutti, la quale idea è sistematicamente smentita dai fatti. Se nel 1960 il 20% più ricco del mondo era 30 volte più ricco del 20% più povero, il divario è aumentato a un rapporto 60:1 nel 1990, crescendo ancora a 1:74 nel 1997, in piena realizzazione delle politiche neoliberiste del Fondo Monetario Internazionale. Oggi le tre persone più ricche del mondo guadagnano ogni anno più dei 48 paesi più poveri messi insieme, e allo sviluppo dei paesi poveri si ha rinunciato, preferendo piuttosto degli aggiustamenti strutturali ovvero «piani di austerità imposti dal FMI per ristabilire la solvibilità dei paesi indebitati proprio a causa di progetti di sviluppo illusori».
L’idea di Latouche è in linea con l’opinione di un suo collega e amico, Gilbert Rist, che paragona il concetto di sviluppo a una stella morta, «che si è già spenta ma di cui continuiamo a vedere la luce»: perché il sogno dello sviluppo è stato smentito dalla realtà, in cui la mano invisibile non esiste e il trickle down effect è solo un pretesto del FMI e del cosiddetto Nord del mondo per imporre politiche di austerità al cosiddetto Sud del mondo. Non solo lo svilluppo è fallito, ma anche lo sviluppo sostenibile è una menzogna (per motivi di cui ho già parlato, ma prima di aver letto Latouche), anzi l’espressione stessa è un ossimoro, in quanto lo sviluppo implica la crescita illimitata, laddove la sostenibilità implica l’adeguamento dei tempi di produzione alle capacità di carico degli ecosistemi e dunque una crescita nulla.
 Del resto, fa notare Latouche, bisogna diffidare delle opinioni in materia economica che trovano approvazione unanime, perché probabilmente sono «parole plastiche» che ciascuno riempie con i contenuti che più gli sono consoni. Il socialista August Bebel, amico di Marx, si chiedeva quale idiozia avesse potuto dire ogni volta che al Reichstag la borghesia lo applaudiva. È partendo da questa considerazione che l’autore critica anche il movimento altermondialista (o almeno una sua componente), reo di continuare a proporre progetti di sviluppo sostenibile, sociale, umano, ecocompatibile noncurante del fatto che il problema è il concetto stesso di sviluppo, a prescindere dall’aggettivo qualificativo che lo segue: anche gli altermondialisti peccano di «sviluppismo», viene rivelato al lettore (ma va? e io che pensavo che il pensiero unico non fosse, appunto, unico) e ciò fa ovviamente comodo al FMI e alle multinazionali, che firmano appelli e manifesti per lo sviluppo sostenibile, e ai politici occidentali, che creano ministeri con quel nome: i più grandi sostenitori dello sviluppo sostenibile sono i più gandi inquinatori e i loro complici.
Del resto, fa notare Latouche, bisogna diffidare delle opinioni in materia economica che trovano approvazione unanime, perché probabilmente sono «parole plastiche» che ciascuno riempie con i contenuti che più gli sono consoni. Il socialista August Bebel, amico di Marx, si chiedeva quale idiozia avesse potuto dire ogni volta che al Reichstag la borghesia lo applaudiva. È partendo da questa considerazione che l’autore critica anche il movimento altermondialista (o almeno una sua componente), reo di continuare a proporre progetti di sviluppo sostenibile, sociale, umano, ecocompatibile noncurante del fatto che il problema è il concetto stesso di sviluppo, a prescindere dall’aggettivo qualificativo che lo segue: anche gli altermondialisti peccano di «sviluppismo», viene rivelato al lettore (ma va? e io che pensavo che il pensiero unico non fosse, appunto, unico) e ciò fa ovviamente comodo al FMI e alle multinazionali, che firmano appelli e manifesti per lo sviluppo sostenibile, e ai politici occidentali, che creano ministeri con quel nome: i più grandi sostenitori dello sviluppo sostenibile sono i più gandi inquinatori e i loro complici.
In tutto questo, circa un centinaio di pagine, Latouche non scrive mai la parola «capitalismo». Due volte ricorre l’aggettivo «capitalistico» e una sola volta si parla di «capitalisti», mentre le ripetizioni di «capitale» si possono contare sulle dita di una mano, e ciò è comprensibile considerato che il concetto può essere usato in un’accezione piuttosto ampia (capitale naturale, capitale umano) sebbene comunque riconducibile ad una visione capitalistica.
Vediamo però cosa intende dire quando parla di «sviluppo».
«…lo sviluppo economico, lanciato da Harry Truman nel 1949 per permettere agli Stati Uniti di impadronirsi degli ex-imperi coloniali europei a impedire ai nuovi Stati indipendenti di cadere nell’orbita sovietica.»
«…l’esperienza occidentale di decollo dell’economia, così come si è realizzato a partire dalla rivoluzione industriale in Inghilterra negli anni 1750-1800…»
«il contenuto implicito o esplicito dello sviluppo è la crescita economica, l’accumulazione di capitale, concorrenza senza pietà, crescita senza limiti delle diseguaglianze, saccheggio sfrenato della natura»
«lo sviluppo può essere definito come un processo che porta a mercificare i rapporti tra gli uomini e tra gli uomini e la natura. Lo scopo è sfruttare, valorizzare, ricavare profitto»
«è lo sviluppo che domina il pianeta da tre secoli a provocare emarginazione, sovrappopolazione, povertà…»
«…lo sviluppo non può non produrre l’ingiustizia sociale…»
«lo sviluppo ha distrutto il locale concentrando sempre di più i poteri industriali e finanziari»
«…forme di redistribuzione sono la bestia nera degli sviluppisti»
«i sistemi di protezione contro la povertà, in particolare la “solidarietà comunitaria”, vengono considerati come ostacoli, freni, resistenze allo sviluppo…»
«con lo sviluppo, il prezzo che si paga sul piano sociale e umano è enorme. Negli anni settanta erano considerate cose “normali” la dittatura, il partito unico, il regime poliziesco, le detenzioni arbitrarie, la tortura o i desaparecidos, se servivano a realizzare il controllo sociale necessario per l’accumulazione “primitiva”»
«non esiste altro sviluppo che lo sviluppo: è inutile cercarne uno migliore, perché in teoria quello che abbiamo va già bene»
Insomma, con sviluppo ci si riferisce alla crescita economica, allo sfruttamento di risorse umane e naturali, alla mercificazione di cose, persone e relazioni, alla disuguaglianza sociale, al predominio dell’economia sulla politica, alla concentrazione dei capitali e dei poteri, a un sistema sociale nato in Inghilterra alla fine del Settecento e di cui gli Stati Uniti sono portabandiera… ma caro Latouche, questo si chiama capitalismo!
Perché questa opera di meticolosa autocensura? Personalmente ho come l’impressione che Latouche abbia paura di esplicitare il proprio anticapitalismo. Pur di non scrivere la parola, inventa delle perifrasi o dei neologismi, come «sviluppismo», «sistema tecnoeconomico», «egoismo dei possidenti», «ricerca del profitto», «corsa al profitto». Biasima chi usa lo sviluppo sostenibile per mascherare ideologicamente lo sviluppo, ma usa lo sviluppo per mascherare ideologicamente il capitalismo.
Insomma, mi sembra che l’opera demistificatoria di decolonizzazione dell’immaginario auspicata nel sottotitolo sia compiuta solo a metà: da un lato si smonta il dogma della crescita e si mostra la fallacia del concetto di sviluppo, dall’altro lo si fa attraverso un’operazione di mistificazione.
Sulle proposte di decrescita (in verità solo accennate negli ultimi due capitoli) mi riservo di scrivere la prossima volta. Nel frattempo, il dibattito è aperto.
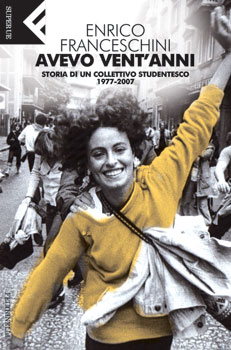
 La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”.
La prima pagina stona con il linguaggio generalmente adottato dal giornale: «esplode la rabbia operaia». Ma il partito di Repubblica non era quello di chi sostiene che le lotte operaie siano ormai acqua passata, insomma una sorta di narcisismo velleitario mantenuto artificialmente in vita dai centri sociali e magari da qualche intellettualoide un po’ retrò? E infatti sì, sono retrò. Volti al passato. Antiprogressisti. Tanto che, come recita il catenaccio sottostante, contestualmente alla protesta degli operai Alcoa «il Pil cala del 2,6%». Se si va a leggere l’articolo sul crollo del Pil, a pag. 6, si scopre che il fatto che il Pil sia calato non è legato alla protesta da un rapporto stretto. O meglio, di certo un legame c’è, visto che il Pil è un indicatore della salute di un’economia capitalistica, ma il rapporto tra le due cose non è di causa-effetto, come sembrerebbe dalla prima pagina. Qual è il significato di questa scelta comunicativa? Consapevolmente o meno, il risultato ottenuto da questo “messaggio subliminale” è proprio l’associazione della «rabbia operaia» al calo del Pil, in un rapporto di causalità. Quindi “attenzione” dice La Repubblica “che a dar ragione a chi vuole un lavoro si torna alle candele e ai somari”. “Da questa crisi usciremo seguendo le direttive dei banchieri, ricchi e intelligenti, non le richieste e i bisogni dei lavoratori, poveri e piuttosto ignoranti”. Quale disperazione può spingere dei lavoratori a pensieri del genere? La stessa che li portava a chiudersi in una miniera a più di trecento metri sotto terra, per diversi giorni. La stessa che portava alcuni dei loro compagni ad incatenarsi ai cancelli del Ministero, rifiutandosi di mangiare, fino a svenire per il caldo e la fame. La stessa che provavano quando, ieri, in cinquecento, hanno trovato ad accoglierli nella capitale più di mille agenti e decine di camionette della polizia. Un corteo barricato anche dall’interno, a cui lo stesso servizio d’ordine dei sindacati confederali permetteva di accedere solo a patto di essere lavoratori dell’Alcoa o tesserati, espellendo dalla manifestazione altre forze di sinistra che solidarizzavano, impedendo così qualsiasi solidarietà di classe, facendo passare l’azione per una protesta per gli interessi particolari dei lavoratori Alcoa.
Quale disperazione può spingere dei lavoratori a pensieri del genere? La stessa che li portava a chiudersi in una miniera a più di trecento metri sotto terra, per diversi giorni. La stessa che portava alcuni dei loro compagni ad incatenarsi ai cancelli del Ministero, rifiutandosi di mangiare, fino a svenire per il caldo e la fame. La stessa che provavano quando, ieri, in cinquecento, hanno trovato ad accoglierli nella capitale più di mille agenti e decine di camionette della polizia. Un corteo barricato anche dall’interno, a cui lo stesso servizio d’ordine dei sindacati confederali permetteva di accedere solo a patto di essere lavoratori dell’Alcoa o tesserati, espellendo dalla manifestazione altre forze di sinistra che solidarizzavano, impedendo così qualsiasi solidarietà di classe, facendo passare l’azione per una protesta per gli interessi particolari dei lavoratori Alcoa. Non molto tempo fa mi sono trovato a percorrere una strada di montagna che costeggia un bosco in cui, da piccolo, andavo con famiglia e amici a raccogliere funghi. Un bel paesaggio, non c’è che dire, dato che il bosco di trova su un pendio da cui è possibile godere di una vista ampia dei monti e della vallata e dei paesini che ne sono ospitati.
Non molto tempo fa mi sono trovato a percorrere una strada di montagna che costeggia un bosco in cui, da piccolo, andavo con famiglia e amici a raccogliere funghi. Un bel paesaggio, non c’è che dire, dato che il bosco di trova su un pendio da cui è possibile godere di una vista ampia dei monti e della vallata e dei paesini che ne sono ospitati. Chi volesse vivere con spontaneità la propria vita e operare le proprie scelte indipendentemente dalle istituzioni, non potrebbe farlo senza correre rischi, o potrebbe farlo soggiacendo alla logica del controllo. Nel primo caso, uno può andare a funghi infischiandosene della normativa in materia, consapevole del fatto che se venisse scoperto da un controllore, una guardia o un funzionario apposito, potrebbe essere punito. Nel secondo caso, si paga e si segue un corso, spendendo soldi e tempo, per poter avere il patentino del raccoglitore di funghi, ma una volta ottenuto si ha la libertà di gestire la propria attività indipendentemente dall’istituzione che lo ha fornito. C’è chiaramente una terza possibilità, se si sopporta male sia la regolamentazione dell’attività che il rischio di incorrere in una punizione: rinunciare all’attività.
Chi volesse vivere con spontaneità la propria vita e operare le proprie scelte indipendentemente dalle istituzioni, non potrebbe farlo senza correre rischi, o potrebbe farlo soggiacendo alla logica del controllo. Nel primo caso, uno può andare a funghi infischiandosene della normativa in materia, consapevole del fatto che se venisse scoperto da un controllore, una guardia o un funzionario apposito, potrebbe essere punito. Nel secondo caso, si paga e si segue un corso, spendendo soldi e tempo, per poter avere il patentino del raccoglitore di funghi, ma una volta ottenuto si ha la libertà di gestire la propria attività indipendentemente dall’istituzione che lo ha fornito. C’è chiaramente una terza possibilità, se si sopporta male sia la regolamentazione dell’attività che il rischio di incorrere in una punizione: rinunciare all’attività. Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione:
Graeber considera la violenza come «l’unico modo in cui è possibile per un essere umano ottenere effetti relativamente prevedibili sulle azioni di un altro, senza esserne consapevole». La violenza ha la capacità di semplificare operando sugli altri «senza essere comunicativa», nel senso che il suo utilizzo rende dispensabili (o minimizza) continui e complessi sforzi di interpretazione reciproca da parte degli attori di una certa situazione: Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».
Con le parole di Graeber, «la qualità più peculiare della violenza –la capacità di imporre relazioni sociali molto semplici che implicano uno sforzo di immaginazione ed immedesimazione minimo o nullo– diventa più importante in situazioni potenzialmente violente, ma nelle quali la violenza fisica effettiva è meno probabile. Tutte queste disuguaglianze sistematiche sono avvalorate dall’utilizzo della forza, e quindi possono essere percepite come una forma di violenza in se stesse: ci si riferisce a tutto ciò con l’espressione “violenza strutturale” […] I sistemi di violenza stutturale sembrano produrre invariabilmente strutture estremamente asimmetriche di “identificazione immaginativa”».
 Si può scrivere un libro che parla sostanzialmente di economia, con contenuti fortemente critici nei confronti del capitalismo, senza mai scrivere la parola «capitalismo»?
Si può scrivere un libro che parla sostanzialmente di economia, con contenuti fortemente critici nei confronti del capitalismo, senza mai scrivere la parola «capitalismo»? e l’assurdità dei cosiddetti «sviluppi particolari»: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo sociale, sviluppo locale e così via, tutti in realtà riconducibili, in un modo o nell’altro, a criteri di natura economica e culturale esclusivi del mondo occidentale e industrializzato e dunque non universali, né di conseguenza esportabili senza distruggere ciò che non si adatta ai parametri occidentali.
e l’assurdità dei cosiddetti «sviluppi particolari»: sviluppo sostenibile, sviluppo umano, sviluppo sociale, sviluppo locale e così via, tutti in realtà riconducibili, in un modo o nell’altro, a criteri di natura economica e culturale esclusivi del mondo occidentale e industrializzato e dunque non universali, né di conseguenza esportabili senza distruggere ciò che non si adatta ai parametri occidentali. Del resto, fa notare Latouche, bisogna diffidare delle opinioni in materia economica che trovano approvazione unanime, perché probabilmente sono «parole plastiche» che ciascuno riempie con i contenuti che più gli sono consoni. Il socialista August Bebel, amico di Marx, si chiedeva quale idiozia avesse potuto dire ogni volta che al Reichstag la borghesia lo applaudiva. È partendo da questa considerazione che l’autore critica anche il movimento altermondialista (o almeno una sua componente), reo di continuare a proporre progetti di sviluppo sostenibile, sociale, umano, ecocompatibile noncurante del fatto che il problema è il concetto stesso di sviluppo, a prescindere dall’aggettivo qualificativo che lo segue: anche gli altermondialisti peccano di «sviluppismo», viene rivelato al lettore (ma va? e io che pensavo che il pensiero unico non fosse, appunto, unico) e ciò fa ovviamente comodo al FMI e alle multinazionali, che firmano appelli e manifesti per lo sviluppo sostenibile, e ai politici occidentali, che creano ministeri con quel nome: i più grandi sostenitori dello sviluppo sostenibile sono i più gandi inquinatori e i loro complici.
Del resto, fa notare Latouche, bisogna diffidare delle opinioni in materia economica che trovano approvazione unanime, perché probabilmente sono «parole plastiche» che ciascuno riempie con i contenuti che più gli sono consoni. Il socialista August Bebel, amico di Marx, si chiedeva quale idiozia avesse potuto dire ogni volta che al Reichstag la borghesia lo applaudiva. È partendo da questa considerazione che l’autore critica anche il movimento altermondialista (o almeno una sua componente), reo di continuare a proporre progetti di sviluppo sostenibile, sociale, umano, ecocompatibile noncurante del fatto che il problema è il concetto stesso di sviluppo, a prescindere dall’aggettivo qualificativo che lo segue: anche gli altermondialisti peccano di «sviluppismo», viene rivelato al lettore (ma va? e io che pensavo che il pensiero unico non fosse, appunto, unico) e ciò fa ovviamente comodo al FMI e alle multinazionali, che firmano appelli e manifesti per lo sviluppo sostenibile, e ai politici occidentali, che creano ministeri con quel nome: i più grandi sostenitori dello sviluppo sostenibile sono i più gandi inquinatori e i loro complici. Ora, è evidente che per evitare crisi come quelle prospettate dal Rapporto sui limiti dello sviluppo occorre raggiungere lo stato stazionario nel consumo delle risorse ambientali, ovvero, per quanto riguarda le rinnovabili, che hanno un tasso di rigenerazione, sfruttarle con una velocità di sfruttamento uguale o minore di tale tasso: tagliare meno alberi di quanti ne ricrescono, pescare meno pesci di quanti ne nascono, e così via.
Ora, è evidente che per evitare crisi come quelle prospettate dal Rapporto sui limiti dello sviluppo occorre raggiungere lo stato stazionario nel consumo delle risorse ambientali, ovvero, per quanto riguarda le rinnovabili, che hanno un tasso di rigenerazione, sfruttarle con una velocità di sfruttamento uguale o minore di tale tasso: tagliare meno alberi di quanti ne ricrescono, pescare meno pesci di quanti ne nascono, e così via.